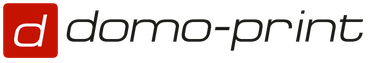Filosofia medievale
La caratteristica principale filosofia medievale dell'Europa occidentale è un il rapporto tra religione e filosofia... La filosofia medievale era cristiana nelle sue intenzioni (obiettivi) ed è stata sviluppata principalmente dal clero (clero). L'immagine cristiana del mondo, le nuove idee su Dio, l'uomo e la causalità hanno avuto un'influenza decisiva sul pensiero medievale e ne hanno posto il tema principale. Ciò non significa che nel Medioevo il pensiero fosse dogmaticamente unificato (uniforme). Disponibilità di vari direzioni filosofiche, la disputa tra di loro, la discussione delle loro tesi da parte delle autorità ecclesiastiche testimoniano che il pensiero si è mosso lungo percorsi culturalmente stabiliti dal cristianesimo e indipendenti dalla chiesa.
A seconda dei compiti che il pensiero filosofico deve affrontare, nonché delle principali domande e risposte ad essi, la filosofia medievale è divisa in due grandi fasi: la patristica (circa II-VIII secolo) e la scolastica (VIII-XV secolo).
Nonostante il fatto che il primo periodo di sviluppo della filosofia medievale - patristica - coincide cronologicamente con l'era dell'antichità, nella sua materia non appartiene più alla cultura antica, ma alla cultura medievale. La necessità di differenziarsi dall'antica tradizione, il desiderio di proteggere l'insegnamento cristiano dal paganesimo, di rafforzarlo con l'aiuto del pensiero antico, stabilirono il pathos del filosofare di questo tempo. I Padri della Chiesa, le cui opere furono poi considerate la base concettuale dell'insegnamento cristiano, risolsero il problema del rapporto tra il cristianesimo e l'antica eredità filosofica utilizzando il linguaggio dei neoplatonici. Quest'ultimo ha portato al fatto che nell'insegnamento cristiano essi notato e portato alla ribalta idee come la dottrina della Trinità, la dottrina del primato dell'anima sul corpo e dello spirituale sul creato.
Il rappresentante più significativo e influente della filosofia cristiana dell'era patristica fu Agostino Aurelio (354-430 d.C.). Le sue opere permeate di neoplatonismo sono una delle principali fonti del pensiero medievale. Inoltre, nelle sue riflessioni sull'esperienza, la coscienza e il tempo, ci sono già approcci che pongono largamente il tema del filosofare del Nuovo Tempo e del presente.
Agostino offre la propria soluzione alla questione del rapporto tra fede e conoscenza, che è significativa per l'intera tradizione medievale: nella fede l'uomo può sviluppare le sue capacità cognitive, mentre la conoscenza conferma la fede. La ricerca dei presupposti della conoscenza porta Agostino alla convinzione che la conoscenza sia giustificata autostima interiore della coscienza... Alla ricerca della conoscenza, non si dovrebbe uscire. Più in profondità in se stesso, una persona troverà verità sovraindividuali e senza tempo (ad esempio, l'idea di unità, l'idea di uguaglianza, i principi della logica), la cui fonte non è l'esperienza sensoriale, ma radiazione divina (illuminazione).
Filosofia dell'era della scolastica
Scolastica (dal lat. scolaro- scuola) si pone come una razionalizzazione della dottrina cristiana. L'obiettivo della scolastica è quello di snellire il dogma e renderlo facile da percepire per la "gente comune" (gli analfabeti). La filosofia è stata riconosciuta come il mezzo principale per ordinare il dogma cristiano per i seguenti motivi:
Con l'aiuto della ragione è più facile penetrare nelle verità della fede;
Usando argomenti filosofici, si può evitare la critica delle verità sante;
Con l'aiuto della filosofia, puoi dare alle verità religiose una forma sistematica e creare un sistema pienamente probatorio della dottrina filosofica.
Le fonti antiche del pensiero scolastico sono la tradizione neoplatonica, Agostino, Boezio. Più tardi, le opere "riscoperte", rilette di Aristotele divennero normative.
La prima scolastica è associata a un risveglio di interesse per la conoscenza. Il pensiero in questo momento era caratterizzato da una maggiore indipendenza nel porre domande.
Tra i principali problemi della prima scolastica c'erano i seguenti:
Il rapporto tra fede e conoscenza;
Il problema degli universali;
Coordinamento della logica aristotelica e delle altre forme di conoscenza;
Riconciliazione tra misticismo ed esperienza religiosa.
Il pensatore più famoso della prima scolastica è Anselmo , arcivescovo Canterbury (1033-1109). Secondo Anselmo, il vero pensiero non può contraddire la fede. Le verità di fede sono fondate sulla ragione naturale. La fede, tuttavia, deve precedere la ragione. Anselmo possiede una prova ontologica essere di Dio.
L'interesse per le opere di Boezio ha suscitato una polemica su universali... Le definizioni universali, cioè generi e specie, corrispondono alla realtà in sé, o esistono solo nel pensiero? Questa controversia portò alla diffusione del metodo scolastico e divenne il tema principale del filosofare per diversi secoli. Alla fine, nella discussione sono stati espressi tre punti di vista:
realismo estremo, il quale sosteneva (continuando così la linea platonica del filosofare) che gli universali, cioè i generi e le specie, esistono prima delle cose, come entità reali;
nominalismo estremo(dal lat. no uomini- nome), che insisteva (risalendo alla tradizione stoica) che generi e ida esistessero dopo le cose, come nomi comuni;
realismo moderato, che si basava sulla tradizione aristotelica: i generi e le specie esistono nelle cose stesse.
Il fiorire della scolastica (XIII secolo) è associato all'emergere delle università. La creazione e lo sviluppo di queste istituzioni di istruzione superiore, l'esistenza di insegnanti qualificati ha portato all'emergere di grandi opere sistematiche.
L'immagine dell'alta scolastica è formata dalla ricezione (prestito e adattamento) delle opere di Aristotele, avvenuta grazie a una nuova conoscenza dei suoi testi da traduzioni dall'arabo, e poi direttamente dal greco. Le opere di Aristotele, insieme agli scritti arabi sul filosofo stesso, nonché i commenti alle sue opere, sono incluse nell'uso universitario. La ricezione neoplatonica araba dello stesso Aristotele e le posizioni neoplatoniche degli scritti attribuiti ad Aristotele portarono a una percezione panteistica dello scienziato. Le autorità ecclesiastiche si opposero a tale comprensione di Aristotele, fino al divieto di leggere e commentare le sue opere. Ma nessun pensatore potrebbe fare a meno di Aristotele, il fondatore della nuova conoscenza. Così, lo sviluppo dell'alta scolastica è segnato dalla "controversia su Aristotele". In questa disputa, i membri degli ordini cattolici si opponevano l'un l'altro francescani orientato verso l'Augustianesimo, e dominicani Orientamento aristotelico. Inoltre, nella tradizione scolastica, va notato lo sviluppo delle direzioni neoplatoniche, delle scienze naturali e della logica.
Fusi insieme aristotelismo, neoplatonismo e agostinismo divennero la base degli insegnamenti del grande sistematista del Medioevo Tommaso d'Aquino (1225-1274), che fece un influente tentativo di snellire la connessione tra aristotelismo e filosofia cristiana.
Tommaso ha dato la sua risposta alla domanda sul rapporto tra fede e ragione. Fede e ragione non possono contraddirsi, poiché entrambe provengono da Dio. La teologia (teologia) e la filosofia non possono giungere a conclusioni diverse. Differiscono, tuttavia, negli approcci: la filosofia va a Dio dalle cose create, la teologia da Dio al mondo creato. La rivelazione di Dio dice alle persone solo quelle verità che sono necessarie per la loro salvezza. Di conseguenza, c'è spazio per un'indagine indipendente su cose che non sono spiegate dalla rivelazione. È questo spazio che la filosofia assimila, assicurando e proteggendo i fondamenti della fede.
L'idea principale tomistico(dal lat. Tommaso- Tommaso) ontologieè completo l'ordine di tutti gli esseri... Ad ogni essere è stata data la sua posizione da Dio e il suo scopo nell'ordine dell'essere è determinato. Tutto ciò che è creato è inerente alla differenza dell'essere e dell'essenza. Solo in Dio il suo essere coincide con la sua essenza.
L'era scolastica tardiva può essere descritta come un'epoca di declino del filosofare medievale. Il nominalismo ha criticato i sistemi metafisici delle vecchie scuole, ma non ha fornito nuove idee. Le vecchie scuole, in un dibattito sulla natura dei concetti generali, difendevano la posizione del realismo moderato. Erano rappresentati sia dai tardi tomisti (seguaci degli insegnamenti di Tommaso d'Aquino) che dalla scuola Johann Duns Scoto (c. 1266-1308). Il nominalismo è venuto all'idea di rimuovere la sintesi di fede e conoscenza. Filosofo inglese e scrittore politico-ecclesiastico William Ockham (c. 1285-1349) ha suggerito che il soggetto delle scienze reali non sono le cose stesse, ma i termini della frase come rappresentanti delle cose.
Lo sviluppo del nominalismo fu accompagnato da una fioritura delle scienze naturali, specialmente a Parigi e Oxford. Inoltre, va notato che lo sviluppo della scolastica non si ferma qui. Benchè scolastica europea moderna perdendo sempre più la continuità della tradizione, continuò a svilupparsi nei secoli XVI e XVII, soprattutto in Spagna e in Italia, come reazione alla Riforma e al Rinascimento. Nel XIX secolo. il cosidetto neoscolastica.
σχολή ) o, più vicino, dal derivato "Scholasticus" - scolastico, educativo. Questo nome di solito denota la filosofia insegnata nelle scuole del Medioevo. La parola "Scholasticus", usata come sostantivo, fu applicata dapprima agli insegnanti di una o più scienze insegnate nelle scuole monastiche fondate da Carlo Magno, nonché agli insegnanti di teologia; in seguito fu trasferito a tutti coloro che erano impegnati nelle scienze, in particolare nella filosofia.Per la prima volta, l'espressione " σχολαστικός "Ricorre, per quanto si sa, in Teofrasto nella sua lettera al suo allievo Fania (Diog. L. V, 2, 37). La parola "scolastico" (e anche "scolastico") non aveva inizialmente lo stesso significato di rimprovero con cui cominciò ad essere usato in epoca moderna, quando la filosofia scolastica o medievale iniziò ad essere attaccata dai rappresentanti del nuovo movimento intellettuale. Ad esempio, molti romani chiamavano Cicerone uno scolastico dopo aver iniziato a studiare la filosofia greca, ma con questo nome volevano designare solo un teorico che dimenticasse l'importanza della pratica e dell'educazione pratica. Ora la parola "scolastica" è applicata non solo alla filosofia medievale, ma anche a tutto ciò che nell'educazione moderna e nel ragionamento accademico assomiglia almeno in parte alla scolastica nel contenuto e nella forma - ed è solitamente usata come epiteto negativo.
caratteristiche generali
Per sua natura generale, la scolastica presenta la filosofia religiosa non nel senso di libera speculazione nel campo delle questioni di carattere religioso e morale, come vediamo nei sistemi dell'ultimo periodo della filosofia greca, ma nel senso di applicare concetti filosofici e metodi di pensiero alla dottrina della chiesa cristiana, la cui prima esperienza rappresenta la filosofia patristica che ha preceduto la scolastica. Tenendo presente attraverso tale applicazione per rendere accessibile alla ragione il contenuto della fede, scolastica e patristica differivano l'una dall'altra in quanto per quest'ultima la Sacra Scrittura fungeva da contenuto, e per la formulazione dogmatica del proprio filosofia - mentre per la scolastica il contenuto della fede era stabilito i padri dei dogmi e la filosofia si applicavano principalmente alla chiarificazione, giustificazione e sistematizzazione di quest'ultima. Non c'è però una contrapposizione assoluta tra scolastica e patristica, perché in epoca patristica, insieme alla graduale formulazione dei dogmi, vi è stata una giustificazione e un loro ordinamento, e d'altra parte non si può dire che anche nel periodo della scolastica il sistema dei dogmi era tutto punti un insieme completo: nel campo della speculazione teologica e filosofica, la dottrina dogmatica ha subito un ulteriore sviluppo.
Il rapporto tra scolastica e filosofia patristica può essere definito più precisamente come segue: la prima realizza e sviluppa ciò che non ha ancora raggiunto la realizzazione e lo sviluppo nella seconda, sebbene fosse in essa come un embrione.
Il filosofare degli scolastici fu costruito sulla base della dottrina consolidata della Chiesa e di quegli insegnamenti della filosofia antica che sopravvissero fino al Medioevo. In questa doppia tradizione teologica e filosofica, il posto più alto, ovviamente, spettava all'insegnamento della Chiesa. Tuttavia, anche la tradizione filosofica godeva di un notevole rispetto: era naturale aspettarsi dai nuovi popoli che stavano appena iniziando a illuminare la scienza che accettassero la scienza che avevano ereditato dall'antichità con fiducia e rispetto infantili. Il compito era riconciliare entrambe le leggende e combinarle in qualcosa di unico. Nello svolgere questo compito, partivano dal principio che ragione e rivelazione provengono da un'unica fonte di luce - da Dio, e che quindi non può esserci contraddizione tra teologia e vera filosofia, e nell'accordo dei loro insegnamenti - prova della verità di entrambi.
Durante il periodo di massimo splendore dei sistemi scolastici, la filosofia e la teologia passavano infatti l'una nell'altra. Tuttavia, la differenza nella loro natura dovrebbe comunque manifestarsi - e alla fine del Medioevo, teologia e filosofia erano già nettamente separate l'una dall'altra.
Il pensiero medievale ha compreso chiaramente la differenza tra queste aree. La filosofia si basava su principi e prove ragionevoli naturali, o, come si diceva all'epoca, sulla "luce naturale", e la teologia era basata sulla rivelazione divina, che era soprannaturale. Alle dottrine filosofiche, la verità è inerente, rispetto alla rivelazione, in misura insignificante; mostrando a quali limiti di conoscenza una persona può raggiungere con le sue forze naturali, la filosofia allo stesso tempo dimostra che non può soddisfare il desiderio della nostra mente di contemplare Dio e la beatitudine eterna e che qui è necessario l'aiuto della rivelazione soprannaturale.
Gli scolastici onoravano gli antichi filosofi come persone che raggiunsero l'apice della conoscenza naturale, ma ciò non significa che i filosofi abbiano esaurito tutta la verità possibile per una persona: il vantaggio della teologia sulla filosofia sta sia nel fatto che ha il principio più alto della conoscenza, e nel fatto che possiede verità superiori che la ragione non può raggiungere da sola. Queste verità schiette costituivano presso gli scolastici in realtà il contenuto essenziale dei loro sistemi, mentre la filosofia serviva solo come strumento ausiliario per i compiti della teologia. Pertanto, hanno detto che la filosofia è serva della teologia (lat. ancilla theologiae). In un duplice senso, è stata una tale serva: primo, ha dato alla teologia una forma scientifica; in secondo luogo, da essa la teologia estraeva quelle verità della ragione, sulla base delle quali poteva sorgere alla comprensione speculativa dei misteri cristiani, per quanto generalmente accessibile allo spirito umano. All'inizio del periodo scolastico, il pensiero filosofico non era ancora sottomesso alla dottrina della chiesa. Quindi, sebbene Eriugena sostenga che tutte le nostre ricerche dovrebbero iniziare con la fede nella verità schietta, nella cui interpretazione dobbiamo sottometterci completamente alla guida dei padri, non accetta di intendere la vera religione semplicemente nella forma di una dottrina sancita per autorità e in caso di conflitto tra autorità e mente dà la preferenza a quest'ultima; gli avversari lo rimproveravano di mancanza di rispetto per l'autorità della chiesa. E dopo Eriugena, l'accordo della ragione con l'insegnamento della chiesa fu raggiunto solo gradualmente. A partire dalla metà del XIII secolo, questo accordo è stato fermamente motivato, con la restrizione, tuttavia, che i dogmi specificamente cristiani (trinità, incarnazione, ecc.) siano stati rimossi dall'ambito di ciò che è dimostrato dalla ragione. Gradualmente (principalmente al momento del rinnovamento del nominalismo nel XIV secolo), la gamma delle proposizioni teologiche, provate dalla ragione, si restrinse sempre più, fino a sostituire finalmente il posto dell'assunzione scolastica della conformità della dottrina della chiesa alla ragione da una completa separazione della filosofia scolastica (aristotelica) dalla fede cristiana.
La visione della filosofia come serva della teologia, sebbene non rigorosamente praticata da tutti gli scolastici, esprimeva tuttavia, si potrebbe dire, la tendenza prevalente del tempo. Il tono e la direzione di tutta la vita spirituale nel Medioevo erano dati dalla chiesa. Naturalmente, la filosofia in questo momento prende anche una direzione teologica e il suo destino è associato a quello della gerarchia: con l'ascesa di quest'ultima raggiunge la sua massima fioritura, con la sua caduta cade. Da ciò, gli storici deducono alcune altre caratteristiche della filosofia scolastica.
Le istituzioni di natura pratica devono essere un sistema strettamente organizzato: questa è una delle condizioni per la loro prosperità. Pertanto, la gerarchia cattolica, nel periodo della sua graduale ascesa, si preoccupò di assemblare il sistema di regole canoniche che doveva essere alla base della sua struttura. Tale sforzo sistematico si riflette nella filosofia del Medioevo, che aspira anche a un sistema e, in luogo degli esperimenti di natura frammentaria, più o meno casuale, del filosofare patristico, fornisce una serie di sistemi più o meno integrali. Ciò è particolarmente evidente nel periodo fiorente della scolastica, quando compaiono i sistemi teologici e filosofici di Alberto Magno, Tommaso d'Aquino e Duns Scoto.
L'attenzione degli scolastici avrebbe dovuto essere già orientata in questa direzione, perché a loro disposizione sin dall'epoca precedente era previsto materiale che richiedeva non discussione critica e non lavoro apologetico-polemico, ma solo sistematizzazione: si trattava generalmente di disposizioni stabilite dalla fede ecclesiale , che doveva essere sottoposto a elaborazione formale utilizzando le tecniche filosofiche disponibili. Questo spiega un'altra caratteristica della filosofia scolastica: la sua gravitazione verso la forma, verso l'elaborazione formale dei concetti, verso la costruzione di conclusioni formali. La scolastica è spesso accusata di formalismo eccessivo e vuoto. Questi rimproveri non sono privi di fondamento; ma bisogna tener presente che un tale formalismo era inevitabile. In altri tempi, il pensiero si è confrontato con la ricchezza e la diversità del contenuto esperienziale; al contrario, il materiale su cui operava la filosofia scolastica era limitato, e le nuove facoltà mentali dei nuovi popoli dovettero trovare la loro via d'uscita in un intensificato lavoro formale.
Il compito generale era assimilare i monumenti del pensiero filosofico ricevuti dal mondo antico e applicarli alle esigenze del tempo. Gli insegnamenti filosofici dell'antichità stavano gradualmente diventando proprietà del Medioevo; dapprima si conoscevano solo scarsi frammenti. All'inizio, il compito era quello di colmare le lacune nella tradizione filosofica, e poi era necessario concordare le autorità filosofiche dell'antichità che non erano sempre d'accordo l'una con l'altra. Inoltre, era necessario applicare la filosofia alla teologia, definire e sostanziare il rapporto della ragione con la fede, trovare una spiegazione razionale delle verità di fede e, infine, creare un sistema filosofico e teologico. Tutto ciò spinse il pensiero medievale principalmente al lavoro formale, anche se, ovviamente, lo portò anche a nuove conclusioni materiali, perché nel filosofare degli scolastici è ingiusto vedere una sola ripetizione in modi diversi di ciò che dicevano Agostino e Aristotele.
I ceti spirituali e secolari durante il Medioevo differivano tra loro nella vita, nelle opinioni, negli interessi e persino nella lingua: gli spirituali usavano la lingua latina, i laici parlavano la lingua del popolo. Certo, la chiesa è sempre stata animata dal desiderio di portare i suoi principi e le sue opinioni nelle masse; ma finché questa aspirazione non si è realizzata - ed è del tutto impossibile realizzarla - il conflitto tra il secolare e lo spirituale ha continuato ad esistere. Tutto ciò che è mondano sembrava allo spirituale, se non ostile, quindi inferiore, estraneo. Pertanto, il contenuto della filosofia scolastica quasi non includeva problemi di natura filosofico-naturale; una considerazione generale, metafisica delle domande sul mondo le sembrava sufficiente; la sua attenzione era rivolta al Divino e ai misteri della salvezza, oltre che all'essere morale dell'uomo; la sua etica, che procedeva dall'opposizione della vita terrena e celeste, del mondo celeste e del mondo sublime, era anche in armonia con il generale distacco dal mondano e dal terreno e la gravitazione verso il celeste.
Lo stesso conflitto tra il secolare e lo spirituale si trova nel linguaggio. Se la scienza, insegnata quasi esclusivamente in latino, era proprietà del clero, allora la poesia — proprio in ciò che in essa era vitale — apparteneva ai laici. Proprio come l'influenza del pensiero scientifico non si riflette nell'arte poetica del Medioevo, perché è di natura troppo fantastica, così la presentazione scientifica in questo periodo è priva di qualsiasi immaginario visivo sensuale: non c'è gusto, nessuna fantasia, nessun l'arte della forma in esso; prevalgono l'artificiosità e l'aridità, insieme al deterioramento del latino classico.
La visione scolastica della scienza
Nel tentativo di fare della teologia una scienza, gli scolastici si sono interrogati non solo su come può essere la scienza, ma anche perché dovrebbe esserlo? Nella cognizione è necessario distinguere tra il suo contenuto e la sua attività. Tra gli scolastici questa distinzione è stata fermamente stabilita perché hanno trovato un'analogia con essa nella fede, dove il lato oggettivo è diverso (lat. fides quae creditur) e soggettivo (lat. fides qua creditur). Il contenuto della fede cristiana è immutabile, mentre l'atto di fede e le modalità di ricezione del suo contenuto cambiano secondo la diversità dei credenti. La Scrittura chiama sostanza il contenuto della fede ( ὑπόστασις , Ebr. XI, 1), e questa definizione si è rivelata feconda per la dottrina scolastica della scienza.
"Sostanza", dice Tommaso, "significa il principio primo di ogni cosa, specialmente nel caso in cui quest'ultimo è contenuto potenzialmente nel primo principio e da esso ha origine completamente; diciamo, ad esempio, che i primi principi indimostrabili formano la sostanza della scienza, perché sono in noi il primissimo elemento di questa scienza e potenzialmente contengono tutta la scienza. In questo senso, fede significa anche la sostanza delle "cose fidate".
La somiglianza tra scienza e fede sta dunque nella struttura organica di entrambe, nella crescita di entrambe dal germe del pensiero. Lo spirito conosciuto e lo spirito che conosce sono reciprocamente subordinati l'uno all'altro. Quest'ultimo contiene embrioni che si sviluppano a contatto con il contenuto della conoscenza. La scienza riceve la sua realizzazione se lo spirito è paragonato al contenuto della conoscenza o, che è lo stesso, se il sigillo dello spirito è impresso su quest'ultimo ( scientia est assimilatio scientis ad rem scitam, scientia est sigillatio scibilis in intellectu scientis). Gli scolastici vedono l'ultimo fondamento di tale accordo tra pensare e concepibile nelle idee che sono nella mente di Dio: le idee in Dio sono l'ultimo fondamento di tutto ciò che è conoscibile; universalia ante rem - assunzione di universalia in re; la visione più alta delle scienze di base è data alla luce del sole della verità divina.
Dunque il soggetto della scienza non sono le cose in quanto separate, sensibili, mutevoli, ma generali e necessarie nelle cose. La conoscenza del separato, come è data dalla percezione sensoriale, ha il suo significato non in sé, ma solo per esigenze pratiche. Un altro take away da di questo concetto sulla scienza sta nel fatto che, sebbene la scienza sia diretta verso il generale, il suo oggetto non ha concetti generali in sé e per sé, ma cose che sono pensate attraverso il loro mezzo: solo la logica è un'eccezione qui. Tali definizioni forniscono alla scienza il suo vero contenuto. Tuttavia, questo si può dire solo di quella direzione del pensiero medievale, che si chiama realismo: il realismo scolastico intende proprio il generale come realmente esistente nelle cose, mentre un'altra direzione opposta - il nominalismo - mette solo concetti, parole e nomi nel contenuto di conoscenza.
La terza conseguenza è che ci sono molte scienze, poiché ci sono molte cose che possono essere loro materia. Non solo la conoscenza dell'individuo come condizione delle azioni private, ma anche la scienza nel suo insieme, gli scolastici hanno attribuito un significato morale e hanno pensato così di dare una risposta alla domanda sul perché la scienza dovrebbe essere. Il filo conduttore qui è stato dato soprattutto dall'idea di saggezza: chi sa deve diventare saggio; l'habitus scientiae da lui acquisito deve assurgere ad habitus sapientiae; il rapporto inferiore, che la scienza forma, deve passare al rapporto superiore. Chi conosce via inquisitionis va dal basso verso l'alto; copre i vari generi scibilum e tratta solo dei molti e del condizionale. Il saggio dai più alti principi, via judicii, va da cima a fondo, abbracciando tutto con un unico sguardo dal punto di vista dell'incondizionato. Le cose umane servono come oggetto specifico della scienza e le cose divine come oggetto della saggezza.
La scienza si accontenta di fissare saldamente il suo argomento; la saggezza va oltre: giudicare e distribuire tutto il resto secondo il suo soggetto. In quanto l'intelletto cerca l'intelletto delle cose raggiungibili in habitus sapientiae per questo in sé stesso intelletto, è intellectus speculativus; poiché dà alla conoscenza un compito ulteriore in relazione a certe azioni compiute dalla volontà, è chiamato intellectus practicus. L'obiettivo del primo è la verità; lo scopo di quest'ultimo è buono. La prima ha una norma, la legge di contraddizione: nulla può essere vero e falso insieme; la seconda norma è seguire il bene ed evitare il male.
Come c'è una doppia luce della conoscenza, naturale e soprannaturale, così c'è anche un doppio habitus dell'intelligenza: scienza e saggezza. Il primo stato è virtù e si ottiene mediante l'attività personale, il secondo è lo stato di grazia dato da Dio. Le tre virtù - ragione, scienza e saggezza - corrispondono allo stesso numero di doni di grazia. La sapienza come virtù conduce alla retta comprensione delle cose divine, in quanto essa si realizza mediante l'investigazione; la sapienza come dono dello Spirito Santo dona la più alta comprensione delle stesse cose che è a nostra disposizione, le quali poi non solo diventano oggetti di comprensione per il saggio, ma così lo catturano in virtù dell'affinità interiore che divina discrere - studiare il divino - sale a divina pati - sperimentare il divino. La conoscenza che possiede la scienza sarebbe incompleta senza un'ascesa alle cose divine, ma non sarebbe completa nemmeno senza il contatto con la vita attiva. La conoscenza deve essere ordinatrice e governativa nella vita, per poi tornare di nuovo al proprio elemento, alla contemplazione.
Questo ideale di saggezza, nota Willman (Geschichte des Idealismus, vol. II, 407), non si trovava tra gli scolastici ad un'altezza irraggiungibile al di sopra dell'attività scientifica; piuttosto, quest'ultimo aveva in sé qualcosa di una saggezza. Il rispetto della tradizione ecclesiale, prevalente nell'insegnamento della pietà, il legame della scuola con la chiesa, che controllava e ordinava quanto indulgeva alla contemplazione, presentava sempre al maestro e all'allievo come un ideale e lo incoraggiava a fare sempre affari come la saggezza richiede, cioè, di avere una mente integra e superiore, e di mantenere la connessione della verità con il bene. Sia la conoscenza che il suo contenuto sono etici.
Il conoscibile è vero, il vero è buono. Le scienze sono arte nel senso più ampio, e tutta l'arte è orientata al bene; il contenuto della scienza è bonum intellectus. Le scienze sono buone; possederli ti obbliga a condividerli. La virtù è dare il pane all'affamato e insegnare all'ignorante con la parola della saggezza. Insegnare e apprendere è un'attività morale. Puoi imparare sulla base di conoscenze preesistenti; da qui l'esigenza dell'insegnante di passare dal facile al più difficile. L'arte dell'apprendimento deve aderire alla natura, come tutta l'arte; le scienze dovrebbero essere studiate secondo il metodo in cui sono state inventate, cioè secondo il metodo naturale. L'atteggiamento della scolastica nei confronti della sapienza conferisce alla scienza l'unità, che nello stesso tempo è smembrata in se stessa. Il sistema delle scienze ha una struttura gerarchica; l'alto determina e illumina l'inferiore, le membra sono insieme ei gradini. Questo sistema è stato presentato più chiaramente da Bonaventura nella sua breve ma ponderata opera "De reductione artium ad theologiam". Procede dalle parole dell'epistola di S. Giacomo: "ogni dono è buono e ogni dono è perfetto dall'alto, procedendo dal Padre delle luci" (Giacomo I, 17) - e sviluppa l'idea di una moltitudine di luci, di fonti di luce o metodi di illuminazione.
Già nel mondo sensibile ci sono due tali fonti di luce che illuminano la nostra vita: una produce il suo effetto benefico se agiamo sulle cose, esercitiamo su di esse le nostre capacità artistiche - ecco perché si verificano le arti meccaniche, a cui Bonaventura, congiunto Hugo S Victor, comprende l'arte della tessitura, del fabbro, dell'agricoltura, della caccia, della navigazione, dell'eloquenza (con l'inclusione della poesia). La seconda fonte di luce del mondo sensibile è formata dalle cose, in quanto agiscono su di noi, producono cognizioni sensoriali e ci mostrano le forme realizzate in natura.
Queste fonti di luce sono luce esterna e luce inferiore; ciò che consegnano è solo preparatorio; una luce più pura ci viene dall'interno, la luce interiore, nella quale vediamo la verità delle cose attraverso la mente; è la luce della scienza in senso stretto, la luce della conoscenza filosofica. Ma al di sopra della luce della ragione c'è la verità della salvezza; al di sopra della luce interiore sta la Luce Superiore, la luce della grazia e della Sacra Scrittura, illuminante mediante la contemplazione della verità salvifica. In esso impariamo il significato e lo scopo dell'illuminazione che fluisce da altre fonti di luce. La Scrittura ci dà un triplice tipo di illuminazione: prima di tutto, fede - fede nella nascita eterna del Verbo e nella sua incarnazione nel tempo; quindi - comportamento o stile di vita; infine, l'obiettivo di entrambi è la beatitudine eterna che scaturisce dalla fede e dalle azioni. La fede è il regno dei maestri, Agostino e Anselmo; comportamento e morale sono opera dei predicatori Gregorio Magno e Bernardo; l'ultima meta con i suoi segreti è opera dei contemplatori, Dionigi e Richard S.-Victor.
La Scrittura ci parla in tre modi: attraverso la sua parola (sermo), attraverso il suo insegnamento (doctrina) e attraverso i suoi comandamenti che regolano la nostra vita (vita). "La multiforme sapienza di Dio, come ci è chiaramente trasmessa nella Scrittura, è nascosta alla base di ogni conoscenza e natura." La Trinità della parola, della dottrina e del comandamento dà lo smembramento della scienza o della filosofia; la verità della ragione è triplice: la verità dei discorsi, la verità delle cose e la verità dei costumi. Tre rami della filosofia sono diretti a queste tre aree di verità: philosophia razionalis, philosophia naturalis e philosophia moralis: la prima esamina la causa della cognizione (causa intelligendi), la seconda - la ragione dell'esistenza (causa subsistendi), la terza - la ordine della vita (ordo vitae). La filosofia razionale si concentra sulla verità del discorso. Ma ogni discorso ha un triplice scopo: esprimere un pensiero, facilitarne l'assimilazione da parte degli altri e persuadere questi a fare qualcosa: significa exprimere, docere, movere, e quindi deve essere appropriato, vero ed efficace - che determina il compito dei tre dipartimenti di filosofia razionale: grammatica, logica e retorica. Se caratterizziamo queste tre scienze con parole: parola (verbum), ordine (ordo) e forma (specie), allora esse riveleranno una traccia della triplice illuminazione della Scrittura, poiché nella parola parlata c'è la nascita e l'incarnazione spirituale, nella severità della formazione dei pensieri si dà qualcosa che corrisponda all'educazione morale e la bella forma del vero pensiero porta la beatitudine spirituale.
La filosofia naturale (naturalis) cerca la verità delle cose e la trova nelle forme mentali delle cose (rationes formales); li trova nella materia, come ragione in seme (rationes seminales) o come forze naturali (virtutes naturales), nello spirito come fondamenti razionali (rationes intellettuali), in Dio come fondamenti ideali (rationes ideales). Di conseguenza, si divide in fisica, che considera le cose nella loro origine e distruzione, matematica, che esplora le forme astratte, e metafisica, che considera l'essere in sé e lo riduce a Dio, come suo colpevole, fine ultimo e prototipo. Anche qui Bonaventura trova un'analogia con la Trinità della Scrittura: la nascita del pensiero formativo, la legge della sua azione e la ricerca di una meta finale soddisfacente. La filosofia morale (philosophia moralis) tratta della verità della vita o della correttezza della volontà. Lei stabilisce questa correttezza per tre aree: per la vita di un individuo, per la vita familiare e per la vita pubblica, e si divide quindi in monastica, oeconomica e politica. Una comprensione completa della filosofia morale si ottiene se prestiamo attenzione a tre significati della parola "rectum": in parte significa l'accordo del mezzo con i fini (rectum, cujus medium non exit ab extremis), in parte la norma con cui il colui che si dirige lungo di esso ( rectum quod dirigenti se conformatur) e, infine, diretto verso l'alto (rectum, cujus summitas est sursum erecta) - definizioni in cui possiamo vedere la natura armoniosa della moralità, vincolante e limitante la natura della legge morale e la sua elevazione al di sopra del terreno.
Bonaventura in rectitudo nel primo senso vede un indizio di quella più alta unanimità che ci è data nel mistero della Trinità, punto centrale della fede, e trova nella sua natura normalizzante l'ordine della vita, nella sua direzione ascendente - un indizio di trasformazione in beatitudine. E in quell'illuminazione, che ci fornisce il mondo sensoriale, in parte come campo della creazione artistica, in parte come base della conoscenza, Bonaventura trova un'analogia con l'insegnamento dogmatico, morale e mistico attraverso la Scrittura. Nell'arte c'è una nascita dallo spirito dell'artista, mediata dalla sua concezione, e in quanto la creazione artistica serve, sia pure debolmente, come parvenza della nascita del Verbo Eterno; poi, nell'arte c'è una norma che rivela il suo effetto disciplinante sull'opera generata - una somiglianza con la regolazione del comportamento attraverso l'ordo vivendi, e questa norma richiede tutte le forze spirituali dell'artista al suo servizio; infine, anche qui, il piacere e la beatitudine sono l'ultimo momento: l'artista gioisce del suo lavoro, l'opera lo loda, lo serve e, se avesse coscienza, si sentirebbe felice. La stessa analogia si osserva nella cognizione sensoriale.
Quindi, da questo punto di vista, l'illuminazione dell'anima con la divina sapienza della Scrittura non è solo il completamento della conoscenza, ma nello stesso tempo il prototipo di tutte le fasi della conoscenza. In virtù della dimora del superiore nell'inferiore, ciò che accade è che sacro. La Scrittura prende in prestito le sue espressioni da tutti i campi della conoscenza, perché Dio è presente in tutti. Come gli scolastici subordinarono la scienza alla saggezza, la filosofia alla teologia, così subordinarono le singole scienze alla filosofia come loro capo. In virtù della struttura gerarchica di S., la filosofia, come quella degli antichi, si trasforma in un vademecum di ricerca rivolto ai singoli ambiti del sapere; ha piena capacità giuridica per questo a causa della sua attrazione per la saggezza, il suo concetto di verità rigorosamente definito, i suoi principi ideali e la sua unità interiore.
Metafisica scolastica
Rappresentando una filosofia religiosa, la scolastica ha avuto il nervo trainante del suo sviluppo nelle esigenze del pensiero teologico, per il quale il filosofare era uno strumento di servizio. Naturalmente, lo sviluppo della filosofia è andato di pari passo con lo sviluppo della teologia; e come il pensiero teologico potrebbe riuscire nel suo movimento sulla base di quanto già realizzato dalle opere dei secoli precedenti, così quello filosofico raggiunge la fioritura e i servizi più versatili che rende alla teologia, più prende coscienza della insegnamenti dei grandi filosofi dell'antichità - Platone e Aristotele, già in epoca patristica riconosciuti come portatori di ogni sapere a disposizione della mente umana naturale.
Ciò è particolarmente evidente nello sviluppo della metafisica scolastica. All'inizio, riceve una direzione originale e, allo stesso tempo, unilaterale. Dall'inizio del Medioevo a quasi la metà del XII secolo, di tutti gli scritti di Platone, si conosceva solo Timeo, tradotto da Calcidio; in altri punti l'insegnamento di Platone era mediocremente conosciuto, poiché entrava nell'ambito dei pensieri dei padri, specialmente di Agostino; era noto anche il terzo libro della composizione di Apuleio: "De dogmate Platonis". Dagli scritti di Aristotele erano noti "Categoriae" e "De interprete" nella traduzione latina di Boezio. Inoltre, hanno familiarizzato con la dottrina logica di Aristotele: l'introduzione di Porfirio in queste opere di Aristotele, anche nelle traduzioni di Boezio e Quiz, poi le opere di Marciano Capella, Agostino, Pseudo-Agostino, Cassiodoro e diversi trattati interpretativi di Boezio ad Aristotele e Porfirio. Sia Analyticae, Topica e De sophisticis elenchis non erano noti dagli scritti logici di Aristotele, e nemmeno dagli scritti riguardanti altre aree della filosofia.
È chiaro che con una tale scarsità di informazioni preliminari di base, lo sviluppo della filosofia nella scolastica inizia in modo peculiare: quasi fino al XIII secolo, la logica, o la dialettica, ha svolto il ruolo di metafisica. Prima dell'inizio della scolastica, la dialettica occupava un posto secondario tra le sette materie insegnate nella scuola, come conoscenza propedeutica ad altre, trattandosi più di parole che di cose; dall'emergere della scolastica, ha preso il primo posto. A causa sua, iniziarono a trascurare tutte le altre "arti libere", cercavano principi per quest'ultimo. La ragione di ciò era che, in assenza di qualsiasi metafisica, si cominciò a cercare una soluzione scientifica alle questioni metafisiche nel campo delle sette scienze scolastiche allora conosciute, e qui era naturale soffermarsi sulla logica, o dialettica, come scienza di carattere filosofico; da esso cominciarono ad estrarre principi metafisici.
Così si espanse il campo di questa scienza, che dapprima si occupò solo della definizione delle parole, quindi catturò la soluzione di tutte le questioni metafisiche e divenne la scienza delle scienze e l'arte delle arti. Partendo dall'idea che qualsiasi proposizione costruita secondo regole logiche è vera, con questa trasformazione della dialettica in metafisica, di solito agivano in modo tale che con le parole intendessero cose, e le semplici congetture furono elevate al livello di verità incrollabili. Di conseguenza, il nome "logica" nel senso di "filosofo" si estese fino alla fine del XII secolo a tutti i seguaci di Platone e Aristotele. Nel XIII secolo, quando la metafisica di Aristotele divenne nota, Alberto Magno ripristinò l'antica distinzione tra dialettica e metafisica: se la dialettica lasciava ancora la soluzione di questioni ontologiche costruite sulla congettura, essa era ancora considerata una scienza solo propedeutica alla conoscenza verità. Tommaso d'Aquino e i suoi seguaci erano della stessa opinione.
Duns Scott alla fine del XIII secolo respinse nuovamente questa distinzione e ritornò alla logica i diritti insoliti per essa. Fino alla fine del XII secolo, la questione del filosofare era solitamente posta in modo tale che ponessero alcune domande, che, a quanto pare, la logica dovrebbe dare una risposta decisiva - e immediatamente, senza esitazione, si affrettarono a dichiarare tutti i punti e tutti i dettagli della loro dottrina, sulla base di speculazioni logiche... Nelle forme didattiche, la presentazione è stata raggruppata attorno a un problema principale. Tale problema, se non comprendeva tutti gli altri, allora che li riguardavano, veniva dato alla scolastica sotto forma di problema sugli universali, o concetti generali. Questo difficile problema è stato presentato alla mente di Aristotele.
I primi scolastici lo trovarono nell'introduzione di Porfirio, tradotta da Boezio, o, più precisamente, nella prefazione a questa introduzione. Qui Porfiry indica tre difficili questioni che lui stesso si rifiuta di risolvere:
- I generi e le specie esistono nella realtà o solo nel pensiero?
- se assumiamo che esistano realmente, sono corporali o incorporei?
- ed esistono separatamente dalle cose sensibili o nelle cose stesse?
Queste tre domande hanno turbato la scolastica per quasi sei secoli. Non potevano prendere le distanze dal risolverli, come fece Porfiry, perché il problema dei generi e delle specie conteneva molti altri importanti problemi. Per gli scolastici questo problema era di particolare importanza che, non avendo una materia speciale per la metafisica, riempirono questa parte della loro filosofia con la sua soluzione. I rappresentanti dell'una o dell'altra soluzione al problema dei concetti generali portavano nomi diversi tra gli scolastici: coloro che attribuivano a questi concetti l'essere reale, le cose isolate e precedenti (universalia ante rem; tuttavia, questo è realismo estremo; il realismo moderato portava la visione aristotelica , che è essere reale comune, ma negli individui c'è un universalia in re); nominalisti - coloro che insegnavano che solo gli individui hanno un essere reale, e generi e specie sono solo generalizzazioni soggettive del simile, fatte attraverso concetti uguali (conceptus) e parole identiche.
Poiché il nominalismo colpisce la soggettività dei concetti attraverso i quali pensiamo agli oggetti omogenei, si chiama concettualismo, e poiché colpisce la somiglianza delle parole, che, per mancanza di nomi propri, denotiamo un insieme di oggetti omogenei, - nominalismo estremo, o nominalismo in senso stretto. La sua formula è universalia post rem. Queste direzioni principali sulla questione degli universali esistono, in parte in embrione, in parte in qualche sviluppo, già nel IX e nel I secolo, ma la loro piena divulgazione, conferma dialettica, polemiche reciproche, nonché l'apparenza delle loro varie possibili modificazioni appartengono a la volta successiva. La questione degli universali, oltre al suo significato scientifico generale, era importante per la scolastica anche perché la sua soluzione era in stretta connessione con l'una o l'altra posizione dottrinale.
Così, per esempio, la dottrina della Trinità delle persone in un solo Dio, sotto la teoria nominalista, è passata alla dottrina del triteismo. Se c'è solo l'individuo e non il generale, insegnava il nominalista Roscellino, allora le tre Persone in Dio devono essere riconosciute come tre Dei e la realtà della loro unità deve essere respinta. Naturalmente, la chiesa ha dovuto reagire negativamente alla visione nominalistica. “Se la chiesa in questa disputa”, nota Erdmann (“Grundriss d. Geschichte d. Philosophie”, 1866, I, 265), “non solo condannava l'eresia dogmatica, ma allo stesso tempo si esprimeva contro i principi metafisici,... allora questo proveniva da una visione assolutamente corretta: chi dà più realtà alle cose che alle idee, è più attaccato a questo mondo che all'ideale regno celeste".
Questi furono i primi passi della metafisica scolastica. L'ulteriore sviluppo di esso nel XIII secolo è già sotto l'influenza della familiarità con tutte le opere di Aristotele; la scolastica in questo momento raggiunge il suo apice. Tuttavia, anche ora lo sviluppo della metafisica non avviene sulla base delle opere di Aristotele appena scoperte: anche le concezioni metafisiche di Agostino, gli elementi ontologici negli scritti areopagiti e le idee di Platone erano importanti come punti di forza.
L'ontologia della scolastica nella sua comprensione delle idee è sin dall'inizio indipendente rispetto ad Aristotele. Alexander Gales respinge decisamente le obiezioni di Aristotele alle idee di Platone. Lo stesso Alessandro accetta i quattro principi di Aristotele, ma chiama il principio della forma: causa exemplaris sive idealis. Alberto Magno scrive De erroribus Aristotelis; Tommaso d'Aquino condanna le polemiche di Aristotele contro l'esplorazione di Platone del significato interiore delle parole; Bonaventura parla delle tenebre egiziane in cui è precipitato Aristotele a causa della negazione delle idee.
In questo momento, la metafisica degli scolastici non meno rivela la sua vitalità superando la pula di cui la filosofia araba monisticamente orientata minacciava di riempire tutto. Averroè riduce l'attività del principio più alto - la forma - ad una semplice separazione delle forme che giacciono nella materia, così che per lui la creazione è solo evoluzione; allo stesso tempo, comprende la mente passiva come una ricettività che si trova negli spiriti umani individuali dall'eternità, e la mente attiva come il deflusso della mente divina diffusa nel mondo, che illumina la mente passiva o percettiva. Alberto e Tommaso confutano con insistenza questo insegnamento, e portano in scena un Aristotele correttamente compreso al posto di uno falsamente interpretato e indicano chiaramente il lato metafisico della questione sollevata. Questa era creativa, che ha fatto della teologia una scienza, è allo stesso tempo il periodo del dominio della metafisica. Quest'ultimo non è insegnato nei libri di testo, ma funge in parte da parte introduttiva di "Somme", in parte costituisce oggetto di piccoli saggi. Entrambe le Somme di Tommaso - filosofica e teologica - sono disposte in modo tale che in esse vadano di pari passo con il contenuto della teologia razionale, i concetti fondamentali dell'ontologia. Anche le sue Quaestiones disputatae trattano argomenti metafisici. Il trattato "De potentia" esprime l'antico problema - come si può diventare molti - che costituiva il nervo della speculazione indiana e che era ancora occupato da Eraclito, Parmenide e altri filosofi greci. Anche il maestro di Thomas, Albert, trattò questo problema, ma con meno successo scientifico del suo grande discepolo.
Visione generale del movimento del pensiero medievale
La storia della filosofia scolastica è divisa più convenientemente in due periodi: il primo dal IX all'inizio del XIII secolo - il periodo della scolastica incipiente, o l'applicazione della logica aristotelica e dei filosofi neoplatonici all'insegnamento della chiesa; la seconda, dell'inizio del XIII secolo. fino alla fine del Medioevo - il periodo del pieno sviluppo e della diffusa diffusione della scolastica, o dell'applicazione al dogma ecclesiastico della filosofia aristotelica, che da allora è diventata nota nella sua interezza. Di regola, l'inizio della filosofia scolastica è visto in quella peculiare e audace rielaborazione di vedute antiche (neoplatoniche), che ha dato a metà del IX secolo. John Scott Eriugena.
La sua prima sezione, che si estende fino alla metà del XII secolo, è caratterizzata dalla predominanza del platonismo; ciò è dovuto all'influenza di Agostino, che trova il suo completamento con Bernardo di Chartres. Allo stesso tempo, attraverso i filosofi arabi ed ebrei, stanno emergendo influenze neoplatoniche, che sono rivelate più chiaramente negli insegnamenti monistici di Amalrich di Bensky e David di Dinant. Il punto di svolta è l'accresciuta familiarità con gli scritti aristotelici, a cui la scolastica deve in parte agli arabi. Giovanni di Salisbury, intorno al 1159, conosce l'intero Organon; intorno al 1200 arriva da Costantinopoli in Occidente una traduzione della Metafisica, ma l'interpretazione della dottrina aristotelica in senso monistico (in cui alcuni seguivano gli arabi) la rende sospettosa agli occhi della chiesa. Papa Gregorio IX nel 1231 ordinò di escludere i libri naturales di Aristotele dall'uso scolastico fino a quando non fossero stati esaminati e scagionati da ogni sospetto di delusione.
Ciò provoca un atteggiamento più cauto nei confronti delle opere famose di Aristotele di recente realizzazione, ma già intorno alla metà del XIII secolo. L'aristotelismo è accolto favorevolmente dai filosofi cristiani; nello stesso tempo, avviene una più ampia assimilazione di antichi metodi di pensiero e inizia un fiorente periodo di scolastica. Il declino del pensiero speculativo e della scolastica inizia nel XIV secolo.
Tuttavia, non si dovrebbe presumere che l'esistenza stessa della scolastica, la sua prosperità e il suo declino dipendessero solo da un più o meno piccolo stock di opere di filosofia antica, e che la filosofia cristiana del Medioevo fosse in una dipendenza servile dagli antichi (specialmente da Aristotele), che peraltro non furono sufficientemente compresi. Come i patristi, gli scolastici cercavano dagli antichi filosofi anzitutto la conferma della verità cristiana; come i patristi, l'intima concordanza degli antichi filosofi con le opinioni cristiane li costringeva ad aderire all'uno o all'altro filosofo.
Platone, nonostante alcune visioni estranee alla fede, si ergeva in alto tra loro perché insegnava l'esistenza di Dio, distingueva l'eternità e il tempo, le idee e la materia, chiamava ragione - l'occhio, la verità - la luce dello spirito, la conoscenza - la visione e fermamente stabilito ciò che è accessibile alla mente creata conoscenza. Aristotele attrasse gli scolastici per le somiglianze che vedevano tra la sua visione organica del mondo e la comprensione cristiana della vita e dello spirito; hanno trovato nella sua dottrina dell'esistenza di Dio e delle proprietà divine la vicinanza agli insegnamenti della Scrittura, nella sua visione che l'anima è una forma del corpo, un'espressione speculativa dell'antropologia biblica. Tutto ciò che dalla filosofia aristotelica è penetrato nell'antico modo di pensare cristiano, si sviluppa dunque anche presso gli scolastici. Allo stesso tempo, hanno apprezzato in Aristotele una persona di pensiero universale e di ampio respiro, hanno visto in lui un rappresentante di quella conoscenza che si ottiene con gli sforzi naturali della ragione, ma con tanto più chiarezza rende possibile comprendere la specificità e l'altezza della fede.
Giovanni di Salisbury, notando i meriti di entrambi i filosofi antichi, aggiunge però che la conoscenza completa, la vera filosofia è possibile solo con la fede, senza la quale gli antichi pensatori cadevano in errore. Così, il rapporto della speculazione medievale con l'antico, con tutto il significato che quest'ultimo aveva, non può essere attribuito a un significato eccezionale nella storia dello sviluppo della scolastica; vanno tenuti presenti anche altri fattori di natura interna. I maestri della chiesa agli occhi degli scolastici avrebbero dovuto stare più in alto dei capi dell'accademia e del liceo. Pertanto, non senza ragione, l'inizio della scolastica non può essere attribuito alla filosofia del pensatore occidentale del IX secolo. I.S.Erigena, e alla teologia del monaco greco dell'VIII sec. Ns. Giovanni Damasceno. Il suo saggio "Πηγή γνώσεως" ("Fonte della conoscenza") offre un compendio della teologia patristica, con un capitolo filosofico introduttivo, e la filosofia agisce direttamente come strumento di servizio della teologia.
In realtà, il capofila della scolastica antica, quando sorse l'esigenza di dare una forma razionale e sistematica al contenuto della fede, fu Agostino. Gli scolastici cercavano la teologia come scienza che unisse tutti gli elementi della religione: positivi, speculativi e mistici. Il primo passo verso questo traguardo è legato al nome di Anselmo di Canterbury (m. 1109); le sue prove dell'esistenza di Dio gettano le basi per la teologia razionale. Il XII secolo porta con sé, da un lato, ad es. Summae, compendi del contenuto positivo della dottrina, dall'altro - aspirazioni mistiche, che si trovano specialmente in Bernard Clairvaux.
Entro il XIII secolo. si riferisce in senso proprio al fondamento della teologia come scienza. Anche Alexander Gales († 1245) dà alla sua Summa una forma di commento alle Massime di Pietro Lombardo, ma al tempo stesso solleva questioni metodologiche generali: la sacra disciplina è necessaria, è sola, se ha carattere pratico o teorico? uno che funge da soggetto, come presentarlo. La sua teologia è saggezza volta a migliorare il cuore, e non a migliorare la conoscenza, come la metafisica o la philosophia prima. Albertus Magnus va oltre: trova che è la saggezza che fa della teologia o sacra disciplina una scienza e la mette in relazione con la filosofia.
Tommaso d'Aquino, infine, dimostra la necessità della saggezza basata sulla fede e il completamento di tutte le conoscenze temporaneamente raggiungibili; è una philosophia prima, un preconcetto, anche se imperfetto, della contemplazione eterna. Qui si avverte l'influenza dei concetti aristotelici, ma i pensieri guida vanno oltre i limiti dell'antica speculazione. Per rimanere a questa altezza occorreva non solo zelo scientifico, ma anche il costante accordo degli elementi della religione, che costituiscono una precondizione per un tale slancio di pensiero. Il mondo scientifico non seppe preservare questo accordo e sotto l'influenza dello spirito dei tempi nei secoli XIV e XV. in parte sprofondato, in parte deviato di lato. La teologia positiva, la mistica e la dialettica si isolarono l'una dall'altra, i punti di vista più alti furono abbandonati, la forza speculativa era in tale stasi che il nominalismo, che poteva essere facilmente sconfitto nel periodo della scolastica incipiente, ora prevaleva.
La scolastica medievale era divisa in due direzioni di pensiero: una, senza mostrare creatività, conservava fedelmente le acquisizioni del periodo fiorente - l'altra mostrava segni di decadenza. Oltre alla causa interna della caduta della scolastica, c'erano altri fattori che vi contribuivano: l'eccitazione dell'interesse per lo studio della natura e il risveglio della conoscenza dell'antichità. Sia l'uno che l'altro avrebbero dovuto essere favoriti dall'aumento a partire dal XIII secolo. studio della filosofia aristotelica. Nella scuola prevaleva ancora il carattere teologico dell'insegnamento; tutte le istituzioni, la cui influenza si rifletteva nella direzione della mente, erano sotto la giurisdizione della chiesa: solo perché la scolastica in sé si disintegrava, un'altra direzione poteva prendere il sopravvento. La disgregazione della scolastica si è rivelata nel Trecento, nella soluzione dell'antica questione filosofica degli universali. Fino al XIV sec. il realismo ha prevalso; ora la preponderanza passa dalla parte del nominalismo.
Affermando che in termini generali si conosce non la vera esistenza delle cose e non i veri pensieri di Dio, ma solo astrazioni soggettive, parole e segni, il nominalismo ha negato ogni significato alla filosofia, che dal suo punto di vista è solo l'arte collegare questi segni in posizioni e conclusioni. Non può giudicare la correttezza delle affermazioni stesse; conoscenza delle cose vere, degli individui, non può fornire. Questa dottrina, fondamentalmente scettica, ha creato un abisso tra la teologia e la scienza secolare. Ogni pensiero del mondo è vanità; si tratta del sensibile, ma il sensuale è solo un fenomeno. Solo la ragione ispirata della teologia insegna i veri principi; solo attraverso di lui impariamo a conoscere Dio, che è individuo e insieme base comune di tutte le cose e quindi esiste in tutte le cose. Ciò è contrario al principio della scienza secolare, secondo cui nessuna cosa può essere simultaneamente in molte cose; ma lo sappiamo per rivelazione, dobbiamo crederci.
Così, nel più netto contrasto, si mettono l'una con l'altra due verità, naturale e soprannaturale: l'una conosce solo i fenomeni, l'altra - la loro base soprannaturale. La teologia è una scienza pratica; ci insegna i comandamenti di Dio, apre la via alla salvezza dell'anima. E proprio come la scienza spirituale e secolare differiscono profondamente l'una dall'altra, così la vita secolare e spirituale dovrebbero essere separate. Il nominalista più ardente, Guglielmo di Ockham, apparteneva ai francescani più severi, i quali, avendo fatto voto di povertà, non si rassegnavano al modo in cui operava il governo pontificio. Il vero spirituale deve rinunciare a tutti i beni terreni, perché considera nulli i fenomeni della vita sensibile. La gerarchia deve quindi rinunciare al potere secolare: i regni mondano e spirituale devono essere separati; la loro confusione porta a disastri. Il regno spirituale ha la precedenza su quello mondano, poiché la verità è sulle apparenze.
La dottrina dello stato spirituale e secolare è stata qui portata ai limiti estremi, dopo i quali ha dovuto seguire una svolta, poiché la completa separazione del potere spirituale e secolare è incompatibile con il concetto di gerarchia. Il nominalismo non poteva diventare una visione generale, ma raggiunse un'ampia diffusione, attrasse il misticismo, affine ad esso nella sua avversione per il clamore mondano, e frantumò i sistemi scolastici in una disputa con il realismo. Ha trasformato la tendenza sistematica della filosofia medievale in una polemica. La disputa tra nominalisti e realisti non fu condotta in modo coerente e non diede frutti fruttuosi: la scomunica prese il posto degli argomenti. Il nominalismo del Medioevo aveva solo un significato negativo per la filosofia. Ha separato la ricerca scientifica dalla teologia, poiché ha rifiutato ogni significato per la vita spirituale dietro le scienze secolari. Sotto la sua influenza nella XIV tavola. la Facoltà di Filosofia nella sua ricerca della verità, non solo per nome, si è separata da quella teologica. La ricerca filosofica ha guadagnato più libertà, ma si è persa nei contenuti. Il formalismo, rimproverato alla scolastica, è oggi infatti preponderante nella filosofia, che si occupa quasi esclusivamente di forme logiche. Qui stanno gli inizi dell'indifferenza religiosa nello sviluppo della scienza secolare; si basa sul principio di dividere il regno spirituale e secolare.
Storia della filosofia scolastica
Periodizzazione
- La prima scolastica (-XII secolo), ancora in piedi sulla base dell'indivisibilità, compenetrazione di scienza, filosofia, teologia, è caratterizzata dalla formulazione del metodo scolastico in connessione con la comprensione del valore specifico e dei risultati specifici dell'attività della ragione e in connessione con la disputa sugli universali. I principali rappresentanti della scolastica: in Germania - Rabanne Maurus, Notker il tedesco, Ugo di San Vittore; in Inghilterra - Alcuin, John Scott Eriugena, Adelardo di Bath; in Francia - John Roscelin, Pierre Abelard, Gilbert of Porretansky, John of Solsbury, Bernard of Chartres, Amalric of Ben; in Italia - Pietro Damiani, Anselmo di Canterbury, Bonaventura.
- La scolastica media (XIII secolo) è caratterizzata dalla definitiva separazione della scienza e della filosofia (soprattutto la filosofia naturale) dalla teologia, nonché dall'introduzione nel pensiero filosofico occidentale degli insegnamenti di Aristotele (vedi filosofia europea), che era disponibile, tuttavia, solo in traduzione latina. Si sta formando la filosofia dei grandi ordini, in particolare gli ordini francescani e domenicani, nonché i sistemi di Alberto Magno, Tommaso d'Aquino, Duns Scoto. Seguì una disputa tra i sostenitori di Agostino, Aristotele e Averroè, una disputa tra i tomisti e gli scotisti. Era il tempo delle grandi enciclopedie filosofiche e teologiche. Altri principali rappresentanti della scolastica: in Germania - Vitello, Dietrich Freiberg, Ulrich Engelbert; in Francia - Vincent di Beauvais, John Zandunsky; in Inghilterra - Roger Bacon, Robert Grossetest, Alexander of Gelsky; in Italia - Egidio di Roma; in Spagna - Raimondo Lullo.
- La tarda scolastica (XIV e XV secolo) è caratterizzata dalla sistematizzazione razionalistica (grazie alla quale la scolastica ha ricevuto un significato negativo), l'ulteriore formazione del pensiero naturale-scientifico e naturale-filosofico, lo sviluppo della logica e della metafisica della direzione irrazionalista, e infine , la definitiva separazione del misticismo dalla teologia della chiesa, che diventava sempre più intollerante. Quando all'inizio. XIV secolo, la chiesa ha già finalmente dato la preferenza al tomismo, la scolastica dal lato religioso è diventata la storia del tomismo. I principali rappresentanti della tarda scolastica: in Germania - Alberto di Sassonia, Nikolai di Kuzansky; in Francia - Jean Buridan, Nikolay Orezmsky, Peter d'Alyi, Nikolay di Otrekur; in Inghilterra - William Ockham; in Italia - Dante; in Spagna - la scuola di Salamanca. Durante il periodo dell'umanesimo, il Rinascimento, la Riforma, la scolastica cessarono di essere l'unica forma spirituale della scienza e della filosofia occidentali. La neoscolastica difende il primato della filosofia cristiana. Scolastico e - corrispondente al metodo della scolastica; in senso negativo: astuto, puramente razionale, speculativo.
Cominciare
Il primo filosofo dell'epoca scolastica è Giovanni Scoto Eriugena, vissuto nel IX secolo e che espose la sua filosofia principalmente nell'opera "De divisione naturae". Nelle sue concezioni filosofiche, aderisce a Pseudodionigi l'Areopagita, di cui tradusse in latino le opere, nonché al suo commentatore Massimo il Confessore, Gregorio Nazianzeno, Gregorio di Nissa e altri maestri della chiesa greca, nonché al latino, vale a dire ad Agostino . La vera filosofia, secondo Erigen, è identica alla vera religione, e viceversa.
Il sistema Eriugena, contenente in sé gli embrioni sia della mistica medievale che della scolastica dialettica, fu rifiutato dalle autorità ecclesiastiche in quanto contraddice la vera fede. Il filosofo cerca di comprendere l'idea cristiana della creazione, spiegandola nel senso della dottrina neoplatonica delle emanazioni. Dio è l'unità più alta; È semplice e tuttavia diversificato. La discesa da Lui è la moltiplicazione del bene divino per la discesa dal generale al particolare; dopo l'essenza più generale di tutte le cose, si formano i generi di una comunità superiore, poi ne segue una meno generale, alle specie, e infine, per differenze e proprietà specifiche, gli individui.
Questa dottrina si basa sull'ipostatizzazione del generale, come prima degli individui, nell'ordine dell'essere di un'essenza realmente esistente - tracce., Sulla dottrina platonica delle idee, come fu poi espressa nella formula: universalia ante rem. Tuttavia, Scott non esclude l'esistenza del generale e del particolare, ma confuta il punto di vista dei "dialettisti" che, basandosi sulle opere di Aristotele e Boezio, sostenevano che l'individuo è una sostanza in senso pieno, mentre il specie e genere sono sostanze in senso secondario. Scott chiama la discesa degli esseri finiti dalla Divinità un'analisi, resolutio; si oppone al ritorno a Dio o deificazione (reversio, deificatio), alla riduzione di un numero infinito di individui a generi e, infine, alla più semplice unità di tutto, che è Dio; quindi Dio è tutto e tutto è Dio. Scott affianca Pseudodionysius nel distinguere tra teologia positiva, che attribuisce predicati positivi a Dio in senso simbolico, e negativa, che li nega in lui in senso proprio.
Realismo e nominalismo dal IX alla fine dell'XI secolo
L'opinione dei "dialettisti" confutata da Eriugena durante e dopo Eriugena trovò numerosi aderenti tra gli scolastici, alcuni dei quali lo difesero direttamente contro la teoria neoplatonica di Eriugena, mentre altri ne riconobbero la vera sostanzialità per il generale. Alcuni dialettici cominciarono a dubitare che il genere potesse essere riconosciuto come qualcosa di reale, materiale, poiché il generale può essere applicato agli individui solo come predicato, e tuttavia non si deve ammettere che una cosa possa essere un predicato di un'altra cosa.
Questo dubbio ha portato all'affermazione che il parto dovrebbe essere riconosciuto solo come parole (voci). Nel risolvere la questione della realtà dei concetti generali, come già accennato in precedenza, si sono formate due direzioni: realismo e nominalismo. Entrambe queste direzioni, in parte in forma embrionale, in parte in qualche sviluppo, si trovano già nel IX e nel IV secolo. La scuola di Raban Mavr (m. 856, arcivescovo di Magonza) aderisce al punto di vista aristotelico-boetico. Tra i suoi rappresentanti, Geirik di Oxerr era incline al realismo moderato. L'allievo di Geirik, Remigio di Oxerres (fine IX secolo), perseguiva una tendenza realistica: insegnava, secondo Platone, che la specie e l'individuo esistono attraverso la partecipazione al generale; Tuttavia, non abbandonò il punto di vista boetico-aristotelico dell'immanenza. Gli studi sulla dialettica, così come sulle arti libere in generale, continuarono ulteriormente, nei secoli Χ e XI, ma quasi fino alla fine di quest'ultimo - senza nuovi risultati scientifici. Tra gli scolastici di questo tempo sono noti: Poppo (X secolo), Herbert (poi Papa Silvestro II, † 1003), Fulberto (XI secolo), il suo allievo Berengario di Tours (999-1088), Ildeberto (1057- 1133), che erano impegnati nell'immagine principale. la questione del rapporto della filosofia con l'insegnamento della chiesa.
Nel 2° sesso. Nell'XI secolo alcuni scolastici cominciarono ad attribuire ad Aristotele l'idea che la logica ha e dovrebbe occuparsi dell'uso corretto delle parole e che i generi e le specie sono solo associazioni soggettive di individui designati con gli stessi nomi; la visione che attribuiva l'esistenza reale agli universali cominciò a essere oggetto di confutazione. Così, il nominalismo è apparso come una direzione opposta al realismo. Il più famoso tra i nominalisti di questo tempo è Roscellin. Il contemporaneo di Roscellino era il suo eccezionale avversario: Anselmo, arcivescovo di Canterbury. Il motto di Anselmo (1033-1109): credo, ut intelligam (vedi Anselmo).
Pierre Abelard (1079-1142) perseguì sulla questione degli universali una direzione estranea sia all'estremo nominalistico di Roscellin sia al realista Wilhelm Champeau (che considerava il genere insito in ogni individuo nell'essenza), ma ancora più vicino al nominalismo (vedi Abelardo). I difensori del platonismo cristiano modificato furono Bernardo di Chartres (nato intorno al 1070-1080), Guglielmo di Comte e Adelario di Bath (entrambi insegnati nella prima metà del XII secolo), i quali, tuttavia, aderirono anche alle opinioni aristoteliche sulla conoscenza del mondo sensibile. Tra i logici-difensori del realismo, Walter de Mortan (+ 1174) e in particolare Gilbert Porretan, compilatore di interpretazioni sullo pseudoboetian "De trinitate" e "De duabus naturis in Christo" e autore di un saggio sulle ultime sei categorie , erano importanti.
Il discepolo di Abelardo Pietro Lombardo (+ 1164), Magister sententiarum, ha compilato un libro di testo di teologia che è stato a lungo la fonte principale dell'insegnamento teologico e della spiegazione dialettica dei problemi teologici. Teologi mistici come Bernardo di Chiaravalle (1091-1153), Ugo (+ 1141) e Riccardo (+ 1173) S.-Victor si ribellarono all'alta reputazione della dialettica, e specialmente alla sua applicabilità alla teologia. Lo studioso ed elegante scrittore Giovanni di Salisbury (+ 1180), che aderì al realismo moderato, si espresse contro la dialettica unilaterale e per il collegamento dell'educazione classica con la teologia scolastica. Alan ab Insulis († 1203) scrisse un'esposizione di teologia basata sulla mente; Amalrico di Bensky (+ 1206) e Davide di Dinant (+ 1209) rinnovarono le dottrine di Dionigi l'Areopagita e di Giovanni Erigena, operando un'identificazione panteistica di Dio con il mondo. Alan de Insulis, David Dinantsky e Amalrich Bensky conoscevano già alcune opere tradotte in arabo.
Filosofia di arabi ed ebrei
Lo sviluppo della filosofia scolastica dalla fine del XII secolo al suo più alto grado di fioritura è dovuto al fatto che gli scolastici, attraverso gli arabi e gli ebrei, e poi i greci, conoscono l'intero corpo delle opere di Aristotele, così come con il modo di pensare dei filosofi che espongono il contenuto di queste opere. ... Da quando, per decreto di Giustiniano (529), la filosofia neoplatonica iniziò ad essere perseguitata in quanto lesiva dell'ortodossia della teologia cristiana, la filosofia aristotelica iniziò a diffondersi sempre più. Gli eretici, e poi i rappresentanti dell'ortodossia, usarono prima di tutto la dialettica aristotelica nelle controversie teologiche.
La scuola nestoriana siriana di Edessa (poi Nisibia) e l'istituto di educazione medico-filosofica di Gandhizapor furono i principali luoghi di studio di Aristotele; prevalentemente da lì la filosofia di Aristotele passò agli Arabi. I monofisiti siriani studiarono anche Aristotele. John Philopon, monofisita e triteista, e il monaco ortodosso St. Giovanni Damasceno erano cristiani aristotelici. Nell'VIII e IX sec. la filosofia è in declino, ma la tradizione tiene ancora. Nell'XI secolo spiccano come logici Michele Psel e Giovanni d'Italia. Dei secoli successivi ci sono molti commenti alle opere di Aristotele, in parte di altri filosofi. Nel XV secolo, soprattutto dopo la caduta di Costantinopoli (1453), iniziò un'intensa conoscenza dell'Occidente con la letteratura antica e, nel campo della filosofia, sorse una lotta tra la scolastica aristotelica e il nuovo platonismo emergente.
La filosofia tra gli arabi rappresenta generalmente l'aristotelismo misto a visioni neoplatoniche. L'arte medica, le scienze naturali e la filosofia greche penetrarono negli arabi principalmente durante l'era del dominio abbaside (dal 750 d.C.), grazie al fatto che i cristiani siriani tradussero nelle lingue siriaca e araba dal greco prima medico, e poi opere filosofiche... La conservazione delle tradizioni della filosofia greca si esprimeva nel fatto che anche ora la connessione tra platonismo e aristotelismo, che dominava tra gli ultimi filosofi dell'antichità, e i soliti teologi cristiani che studiavano la logica aristotelica come forma formale, raggiungeva qui una grande importanza che tra i neoplatonici e i cristiani. La dottrina naturale-scientifica di Aristotele si sviluppò qui con ancor più successo grazie al collegamento tra studi filosofici e studi medici. Il più famoso dei filosofi arabi in Oriente: Alkendi (prima metà del IX secolo), ancor più famoso come matematico e astrologo; Alfarabi (X secolo), che assimilò la dottrina neoplatonica delle emanazioni; Avicenna (XI secolo), che difese l'aristotelismo più puro e fu molto stimato anche tra gli studiosi cristiani del tardo medioevo come filosofo e soprattutto come medico scienziato; infine, Algazel (d. XII secolo), nell'interesse della teologia l'ortodossia ricorreva allo scetticismo filosofico.
In Occidente: Avempats (XII secolo, Ibn Badja) e Abubatser (XII secolo, Ibn Tophail), che pensavano allo sviluppo graduale indipendente dell'uomo; Averroè (Ibn Roschd, 1126-1198), famoso commentatore di Aristotele. Interpretando la dottrina di quest'ultimo sulla mente passiva e attiva, Averroè assume un punto di vista panteistico, che esclude l'immortalità individuale; riconosce un solo intelletto comune a tutta l'umanità, smembrato nelle singole persone e riconducendo nuovamente a sé ciascuna delle sue emanazioni, così che solo in lui esse vengono coinvolte nell'immortalità. La filosofia degli ebrei nel Medioevo fa parte della Kabbalah, parte dell'insegnamento platonico-aristotelico trasformato. Alcune disposizioni cabalistiche possono essere attribuite al I secolo. o prima dell'inizio dell'era cristiana; sono probabilmente collegati con l'insegnamento segreto degli Esseni.
L'ulteriore educazione di questa dottrina è stata significativamente influenzata dalla visione greca, in particolare platonica, attraverso, forse, la filosofia religiosa giudeo-alessandrina e, successivamente, gli scritti neoplatonici. Il contatto con civiltà aliene, in particolare con quella persiana, poi con quella ellenica e romana, e poi con il cristianesimo e il maomettanesimo, allargò gli orizzonti del popolo ebraico e portò progressivamente alla distruzione dei confini nazionali nel campo della fede. Tra i filosofi ebrei, più significativo è Saadia-ben-Joseph-al-Fayumi (dall'892 al 942), difensore del Talmud e oppositore dei Caraiti; un rappresentante della corrente neoplatonica, vissuto in Spagna intorno al 1050, Solomon Ibn-Gebirol, riconosciuto dagli scolastici cristiani come filosofo arabo e da loro indicato con il nome di Avicebron; Bahia ben Joseph, autore di un saggio morale sui doveri del cuore (fine XI secolo). Una reazione diretta in filosofia fu fatta intorno al 1140 dal poeta Giuda Halevi nel suo libro Khosari, dove la filosofia greca, la teologia cristiana e maomettana sono esibite dagli insegnamenti ebraici conquistati.
A metà del XII secolo, Abraham ben David tentò di fare un confronto tra la filosofia ebraica e quella aristotelica; con più significativo successo, il più famoso tra i filosofi ebrei del Medioevo, Maimonide (Mosè Maimonide, 1135-1204), assunse questo compito nel suo saggio: "Una guida ai dubbiosi". Attribuisce ad Aristotele un'autorità incondizionata nella conoscenza del mondo sublunare, nella conoscenza del celeste e del divino limita le sue opinioni a un insegnamento franco. Levi ben Gerson (prima metà del XIV secolo) è noto come commentatore di Parafrasi e Commentari di Averroè, nonché autore delle proprie opere. Attraverso gli ebrei, le traduzioni arabe delle opere di Aristotele e degli aristotelici furono tradotte in latino, e in questo modo la conoscenza della filosofia generale aristotelica raggiunse gli scolastici cristiani, che iniziarono essi stessi a tradurre le opere di Aristotele direttamente dal greco.
Sviluppo e distribuzione
La conoscenza degli scritti di Aristotele, così come delle opere di filosofi arabi ed ebrei basati in parte sul neoplatonismo, in parte sull'aristotelismo e sulla logica bizantina, fece un significativo ampliamento e trasformazione degli studi filosofici degli scolastici cristiani. In alcuni di questi scritti, specialmente in quelli dapprima falsamente attribuiti ad Aristotele, ma che in realtà devono la loro origine al neoplatonismo, si sviluppa la teosofia emanatistica. Contribuì all'emergere di dottrine panteistiche aderenti agli insegnamenti di John Scott Erigena, contro le quali presto sorse una forte reazione della chiesa, minacciando in un primo momento di toccare la filosofia naturale e la metafisica aristotelica.
Più tardi, quando fu riconosciuto il carattere teistico degli attuali scritti di Aristotele, cominciarono ad essere usati contro il platonismo, mutuati dai primi scolastici da Agostino e dai padri della chiesa. Il primo filosofo scolastico che studiò l'intera filosofia di Aristotele e parte dei commentari dei filosofi arabi e rivolse tutto questo al ministero della teologia cristiana fu Alexander Gales (+ 1245); nella sua "Summa theologiae" presenta un fondamento sillogistico dei dogmi ecclesiastici, per i quali utilizza insegnamenti filosofici. La sua creazione non è la prima ad avere un tale titolo; c'erano anche Summaes precedenti, ma i loro autori usavano solo la logica di Aristotele e non tutta la sua filosofia.
Guglielmo d'Alvernia, vescovo. parigino (+ 1249), difese la dottrina platonica delle idee e la sostanzialità dell'animo umano contro Aristotele e gli aristotelici arabi; identificava la totalità delle idee con la seconda persona della Santissima Trinità. Roberto, vescovo. Lincoln (+ 1252), collegava la dottrina platonica con quella aristotelica. Michael Scott è meglio conosciuto come traduttore di scritti aristotelici che come scrittore indipendente. Vincenzo di Beauvais (+1264) è più un enciclopedista che un filosofo. Il mistico Bonaventura (+ 1274), allievo di Alessandro Gales, preferiva l'insegnamento di Platone a quello di Aristotele e subordinava tutta la saggezza umana all'illuminazione divina. Al di sopra della morale popolare, secondo lui, c'è l'adempimento dei voti monastici e soprattutto la contemplazione mistica, che dà l'anticipazione della beatitudine futura. Albert Bolshtadt (1193-1280), soprannominato il Grande (Albertus Magnus), o "doctor universalis", fu il primo scolastico che riprodusse in modo sistematico l'intera filosofia aristotelica, tenendo costantemente conto dei commentatori arabi, e la sviluppò nel senso del dogma della chiesa.
introduzione
La proposta il lavoro di controllo è un esame del periodo filosofico scolastico che è apparso nel Medioevo.
Questo obiettivo si realizza risolvendo quanto segue compiti:
- · Considerazione della questione della nascita e della fioritura della scolastica, per definire questo termine;
- · Descrizione dettagliata le principali direzioni della scolastica, così come il loro scontro, le dispute sugli universali;
- · Allocazione di personalità significative, seguaci e oppositori delle tendenze scolastiche;
- · Considerazione delle cause della crisi della scolastica.
L'emergere della scolastica e le sue principali direzioni: nominalismo e realismo
Scholamstica (dal greco uchplbufikt - scienziato, Scholia - "scuola") è una filosofia medievale europea sistematica, concentrata attorno alle università e che rappresenta una sintesi della teologia cristiana (cattolica) e della logica di Aristotele.
La filosofia alla fine dell'VIII - inizi del IX secolo veniva insegnato solo nelle scuole del monastero, dove lo studiavano i futuri sacerdoti e ministri della chiesa. Il compito della filosofia non era lo studio della realtà, ma la ricerca di vie razionali della verità della prova di tutto ciò che la fede proclamava. Da qui il nome - scolastica.
La scolastica iniziò nel IX secolo e continuò fino alla fine del XV secolo. Era solo di natura religiosa, il mondo, secondo le idee degli scolastici, non ha nemmeno un'esistenza autonoma, tutto esiste solo in relazione a Dio.
Il metodo della filosofia scolastica era predeterminato anche nella sua ipotesi. è non di trovare la verità che è già stata data nella rivelazione, ma di esporre e provare questa verità per mezzo della ragione, cioè filosofia. Ne conseguono tre obiettivi: primo - con l'aiuto della ragione è più facile penetrare nelle verità della fede e avvicinare così il loro contenuto allo spirito pensante dell'uomo, secondo - dare alla verità religiosa e teologica una forma sistematica con l'aiuto di metodi filosofici; terzo - usare argomenti filosofici per escludere la critica delle verità sante. Tutto questo non è altro che il metodo scolastico nel senso lato del termine, in cui prevale il formalismo.
Nel senso stretto del termine, il metodo scolastico consiste in un'operazione formalmente logica di inferenza da tesi opposte, obiezioni "pro" e "contro" individuando differenze, si traggono conclusioni che servono a usare questa "dialettica" scolastica per confermare la contenuto speculativo del cristianesimo. Allo stesso modo, lo studio della realtà si svolge in questo modo logico-formale e serve le esigenze della sua riproduzione in modo religioso. L'essenza della "dialettica" scolastica è il suo ragionamento formale su concetti, categorie senza considerare il loro reale contenuto. Tutto è soggetto all'autorità della dottrina cristiana. In sostanza, questa "dialettica" si riduceva a un giudizio sillogistico in cui la realtà viva, concreta, scompariva e si deformava. Lo scopo principale della filosofia scolastica era una fusione diretta con la teologia.
Il fondatore della scolastica è considerato John Scott Eriugena(ca 810-877), insegnante alla corte reale di Carlo il Calvo a Parigi. Era un grande scienziato del suo tempo, conosceva il greco (scriveva poesie in esso), tradotto dal latino. Eriugena era originaria dell'Irlanda, dove i testi dei Padri della Chiesa greci iniziarono a circolare nelle scuole monastiche.
Fu uno dei primi a proporre una tesi che vale per tutta la scolastica: la vera religione è anche la vera filosofia e viceversa; i dubbi sollevati contro la religione confutano anche la filosofia. Ha difeso con vigore la tesi che non c'è contraddizione tra rivelazione e ragione. Lo strumento della ragione è la dialettica, che egli comprende, come Platone, cioè. come l'arte di confrontarsi con punti di vista opposti nella conversazione, per poi superare le differenze per mettere in luce la verità. Il ruolo decisivo nella cognizione, secondo Eriugena, ha concetti comuni. I concetti singoli, al contrario, esistono solo per il fatto che appartengono alla specie e la specie al genere. Questa direzione della riflessione filosofica nel corso dell'ulteriore sviluppo della filosofia medievale fu chiamata realismo.
Il pensiero filosofico scolastico si è concentrato essenzialmente su due questioni: da un lato, sulla disputa tra nominalismo e realismo, dall'altro, sulla prova dell'esistenza di Dio. La base filosofica della disputa tra realismo e universalismo era la questione del rapporto tra il generale e l'individuo, l'individuo.
Realismo ( dal lat. realis - reale, valido). I realisti estremi aderivano alla dottrina platonica delle idee; il generale sono le idee che esistono prima e fuori delle cose individuali (ante res). I fautori del realismo moderato procedevano dalla dottrina aristotelica dei generi generali, secondo la quale il generale esiste effettivamente nelle cose (in rebus), ma in nessun caso al di fuori di queste cose.
Candidati ( dal lat. nomen - nome), al contrario, non consentiva l'esistenza reale degli universali, il generale esiste solo dopo le cose (post res). Gli aderenti all'ala estrema del nominalismo consideravano il generale solo un vuoto, che non conteneva nulla di "respiro di voce", il lato sano della parola. Anche i più moderati negavano la realtà del comune nelle cose, ma lo riconoscevano come pensieri, concetti, nomi che giocano un ruolo importante nella cognizione (concettualismo).
Affermando che nei concetti generali non è conosciuta la vera esistenza delle cose e non i veri pensieri di Dio, ma solo astrazioni soggettive, parole e segni, il nominalismo ha negato ogni significato dietro la filosofia, che, dal suo punto di vista, è solo l'arte di collegare questi segni in posizioni e conclusioni ... Non può giudicare la correttezza delle affermazioni stesse; conoscenza delle cose vere, degli individui, non può fornire. Questa dottrina, fondamentalmente scettica, ha creato un abisso tra la teologia e la scienza secolare. Ogni pensiero del mondo è vanità; si tratta del sensibile, ma il sensuale è solo un fenomeno. Solo la ragione ispirata della teologia insegna i veri principi; solo attraverso di lui impariamo a conoscere Dio, che è individuo e insieme base comune di tutte le cose e quindi esiste in tutte le cose.
Gli aderenti al realismo furono, in particolare, Anselmo di Canterbury, Tommaso d'Aquino; sostenitori del nominalismo - John Roscelin, John Duns Scotus, William Ockham. Pierre Abelard ha preso una posizione speciale, sostenendo che gli universali esistono nelle cose. Questa posizione è stata chiamata concettualismo.
SCOLASTICISMO(Latina scholastica dal greco σχολαστικός - scuola) - un tipo di filosofia religiosa caratterizzato dalla subordinazione fondamentale al primato della dottrina teologica, dalla combinazione di premesse dogmatiche con metodi razionalistici e da uno speciale interesse per i problemi logici; ha ricevuto lo sviluppo più completo in Europa occidentale durante il Medioevo maturo e tardo.
GENESI DELLA SCOLASTICA E PERIODIZZAZIONE DEL SUO SVILUPPO. Le origini della scolastica risalgono alla filosofia tardoantica, in primis al neoplatonico del V secolo. Proclo (impostazione per leggere le risposte a tutte le domande da testi autorevoli, che erano le opere di Platone per Proclo, nonché testi sacri dell'antico paganesimo; sintesi enciclopedica di una varietà di problemi; combinare i dati di un mito interpretato misticamente con il loro sviluppo razionale) . La patristica cristiana si avvicina alla scolastica man mano che il lavoro sui fondamenti dogmatici della dottrina della chiesa è completato ( Leonty bizantino , Giovanni Damasceno ). Di particolare importanza è stato il lavoro Boezio sul trasferimento della cultura greca della riflessione logica alla tradizione latina; la sua osservazione fatta nel corso del commento su un'opera logica (In Porph. Isagog., MPL 64, col. 82-86) e rilevando come questione aperta se i concetti generali ( universali ) solo dalla realtà intralinguistica, o hanno uno statuto ontologico, hanno dato luogo a una discussione su questo tema durata secoli e costitutiva della scolastica. Coloro che vedevano i realia negli universali erano chiamati realisti; coloro che vedevano in loro una semplice designazione (nomen, letteralmente "nome") per l'astrazione creata dalla coscienza umana erano chiamati nominalisti. tra puro realismo e pulito nominalismo come due possibilità polari c'era uno spazio mentale per varianti moderate o complicate.
La prima scolastica (dal IX al XII secolo) ha monasteri e scuole monastiche come terreno socioculturale. Nasce in drammatiche dispute sul luogo del cosiddetto. dialettica (cioè ragionamento metodico) nella ricerca della verità spirituale. Posizioni estreme del razionalismo ( Berengario di Tours ) e fideismo ( Pietro Damiani ) non poteva essere costruttivo per la scolastica; la via di mezzo era suggerita dalla formula che risale ad Agostino Anselmo di Canterbury "Credo, ut intelligam" ("Credo per capire" - nel senso che la fede è primaria come fonte di punti di partenza, che sono poi soggetti allo sviluppo mentale). Iniziative di pensiero di un innovatore audace Abelardo e altri teologi del XII secolo. ( Scuola di Chartres , Scuola San Vittore ) contribuì allo sviluppo del metodo scolastico e preparò il passaggio all'era successiva.
L'alta scolastica (XIII-inizio XIV secolo) si sviluppa nell'ambito del sistema universitario fondato in tutta Europa; sfondo è la partecipazione attiva alla vita mentale del cosiddetto. ordini mendicanti - domenicani e francescani rivali. Lo stimolo intellettuale più importante è la conoscenza diffusa dei testi di Aristotele, così come dei suoi commentatori arabi ed europei. Si condanna, invece, il tentativo di introdurre nella circolazione scolastica quelle tesi aristoteliche e averroiste che erano incompatibili con i fondamenti della fede cristiana (causa Seeger del Brabante ). La direzione dominante, espressa principalmente nella creatività Tommaso d'Aquino , si adopera per una sintesi coerente di fede e conoscenza, per un sistema di livelli gerarchici, all'interno del quale dogmi dottrinali e speculazioni filosofico-religiose sarebbero integrate dalla riflessione socio-teorica e naturale-scientifica basata su Aristotele; trova terreno nell'ambito dell'Ordine domenicano, dapprima incontra la protesta dei conservatori (la condanna di alcune tesi da parte del Vescovo di Parigi nel 1277, seguita da atti simili a Oxford), ma poi sempre più spesso e per secoli è percepita come una versione normativa della scolastica. Tuttavia, il pluralismo autoritario, dato dalla parallela convivenza di ordini diversi nel medioevo maturo nel cattolicesimo, crea un'opportunità per lo sviluppo, anzitutto, all'interno dell'ordine francescano di una scolastica alternativa, rappresentata dalla metafisica mistica orientata verso l'agostiniano. Platonismo. Bonaventura , spostando l'accento dall'intelletto alla volontà e dall'astratto al singolare (haecceitas, "è così") in Giovanni Duns Scott eccetera.
La tarda scolastica (XIV-XV secolo) fu un'epoca ricca di crisi, ma non un'era affatto sterile. Da un lato, i domenicani ei francescani rielaborano le iniziative creative di Tommaso d'Aquino e Duns Scoto, rispettivamente, in sistemi conservatori di tomismo e bestialità; dall'altro, si sentono voci che chiedono il passaggio dalla speculazione metafisica a uno studio empirico della natura, e dai tentativi di armonizzare fede e ragione, a una separazione volutamente netta dei compiti di entrambi. Un ruolo speciale è svolto dai pensatori britannici contrari alla creazione di sistemi speculativi dell'alta scolastica continentale: R. Bacon richiede lo sviluppo di conoscenze specifiche, W. Okkami propone uno sviluppo estremamente radicale delle tendenze bestiali verso il nominalismo estremo e suffraga teoricamente le pretese dell'impero nei confronti del papato. Da segnalare la revisione protocapitalista del concetto scolastico di "prezzo equo" da parte dell'occamista tedesco Gabriel Biel (1420-1495 circa). Alcuni aspetti dell'eredità mentale di questo periodo, revisione e critica dei precedenti fondamenti della scolastica sono stati successivamente assimilati dalla Riforma.
METODO SCOLASTICO. Sottomissione del pensiero all'autorità del dogma - secondo la nota formula che risale a Pietro Damiani (De divina omnipotentia, 5, 621, MPL, t. 145, col. 603), philosophie ancilla theologiae, «la filosofia è la servo della teologia" - è inerente alla scolastica ortodossa insieme a tutti gli altri tipi di pensiero religioso della chiesa ortodossa; ciò che è specifico della scolastica è che la natura stessa del rapporto tra dogma e ragione è stata concepita con indubbio autoritarismo come insolitamente razionale e orientata verso l'imperativo della sistemicità interna ed esterna. Sia la Sacra Scrittura e la Santa Tradizione, sia l'eredità della filosofia antica, attivamente rielaborata dalla scolastica, hanno agito in essa come un grandioso supertesto normativo. Si presumeva che tutta la conoscenza avesse due livelli: conoscenza soprannaturale, data nella Rivelazione di Dio, e conoscenza naturale, ricercata dalla mente umana; la norma della prima contiene i testi della Bibbia, accompagnata dagli autorevoli commentari dei Padri della Chiesa, la norma della seconda, i testi di Platone e soprattutto di Aristotele, contornata dagli autorevoli commentari dei filosofi tardoantichi e arabi ( caratteristicamente diffusa nella scolastica matura, la designazione di Aristotele come praecursor Christi in naturalibus, cioè tutto ciò che riguarda le cose naturali”). Potenzialmente, in entrambi i testi, la pienezza della verità è già data; per attualizzarlo è necessario interpretare il testo stesso (il genere della lectio, letteralmente “lettura”, che era il genere originario del discorso scolastico, indica l'interpretazione di un brano scelto della Bibbia o, meno spesso, di qualche autorità, ad esempio Aristotele), poi dedurre l'intero sistema delle loro conseguenze logiche con l'aiuto di una catena continua di inferenze correttamente costruite (confrontare il genere caratteristico della scolastica somme - l'opera enciclopedica finale, il cui presupposto è fornito dal genere delle massime). Il pensiero della scolastica resta fedele all'epistemologia dell'idealismo antico, per il quale è comune il vero soggetto della conoscenza (cfr. la teoria delle idee di Platone e la tesi di Aristotele: "ogni definizione e ogni scienza tratta del generale", Met. XI, p. 1, p. 1059b25, trad. A.V. Kubitsky); segue costantemente la via della deduzione e quasi non conosce l'induzione, le sue forme principali sono la definizione, lo smembramento logico e, infine, un sillogismo che deduce il particolare dal generale. In un certo senso, tutta la scolastica è filosofare nelle forme dell'interpretazione del testo. In questo essa presenta un contrasto sia alla moderna scienza europea con il suo desiderio di scoprire verità finora sconosciute attraverso l'analisi dell'esperienza, sia al misticismo, con il suo desiderio di vedere la verità nella contemplazione estatica.
Una paradossale, ma logica aggiunta all'orientamento della scolastica verso un testo autorevole fu la selezione delle autorità del sapere "naturale", inaspettatamente libere da motivazioni confessionali e religiose; insieme ad antichi pagani come Platone, Aristotele o l'astronomo Tolomeo, e pensatori della cultura islamica come Averroè ( Ibn Rushd ) il canone della scolastica matura includeva, ad esempio, un ebreo spagnolo Ibn Gebirol (XI secolo), noto come Avicebronn (peraltro, gli scolastici cristiani che lo citavano ricordavano che non era cristiano, ma dimenticavano come inutili informazioni sulla sua nazionalità e appartenenza religiosa, chiarite solo da ricercatori del XIX secolo). A tal proposito, si segnala che il cd. teoria della doppia verità (la stessa tesi può essere vera per la filosofia e falsa per la fede), decisamente respinta dal tomismo, ma attribuita, ad esempio, a Siger di Brabante ed essendo il limite logico di molte tendenze della tarda scolastica, è in certa misura conseguenza autoritarismo scolastico: la Bibbia ei Padri della Chiesa - autorità, ma anche Aristotele e Averroè, che li contraddicono, erano percepiti proprio come autorità. Inoltre, la scolastica non sarebbe un periodo creativo nella storia del pensiero se trovasse risposte pronte nei dati di testi autorevoli, e non domande, non difficoltà intellettuali che provocano un nuovo lavoro della mente; è proprio l'impossibilità di risolvere i problemi con l'aiuto di un solo riferimento all'autorità, che sostanzia la possibilità stessa della scolastica, che è diventata più volte oggetto di tematizzazione. "Auctoritas cereum habet nasum, id est in diversum potest flecti sensum" ("L'autorità ha un naso di cera, cioè può essere girato sia di là che di là"), notò il poeta e scolastico Alan Lille , mente. 1202 ( Alanus de Insulis... De Fide Cath. I, 30, MPL, t. 210, 333A). Tommaso d'Aquino si oppone specificamente all'atteggiamento della mente verso un atteggiamento passivamente dossografico nei confronti delle autorità: "La filosofia non si occupa di raccogliere le opinioni di varie persone, ma di come stanno realmente le cose" (In librum de caelo I, 22). I pensatori scolastici erano attratti dalla considerazione di problemi ermeneutici particolarmente complessi; Un caso particolare è stata la contraddizione verbale tra testi autorevoli, non senza ragione accentuata nel titolo dell'opera di Abelardo "Sì e no" (Sic et non). Lo scolastico doveva essere in grado di comprendere tali incidenti, operando nelle categorie della semantica (polisemia di una parola), semiotica (significati simbolici e situazionali-contestuali, adattamento della forma del discorso teologico alle abitudini linguistiche dell'ascoltatore o del lettore, eccetera.); teoricamente si formula anche la questione dell'autenticità della composizione e della critica del testo, sebbene tali problemi filologici al servizio della teologia nel suo insieme rimangano atipici per il Medioevo e costituiscano una conquista caratteristica della moderna cultura europea.
L'influenza della scolastica sulla cultura contemporanea è stata pervasiva. Incontriamo la tecnica scolastica di smembrare i concetti nei sermoni e nelle vite (molto vividamente - nella "Leggenda d'oro" di Jacob Voraginsky), i metodi scolastici di lavorare con la parola - nella poesia in lingua latina dall'innografia alle canzoni di vagabondi e altri puramente mondani generi (e attraverso la letteratura in lingua latina - anche e nella letteratura in lingue popolari); l'allegorismo scolastico è vividamente sentito nella pratica delle arti visive.
L'orientamento a regole di pensiero rigidamente fissate, la rigorosa formalizzazione del patrimonio antico hanno aiutato la scolastica a svolgere il suo compito di "scuola": portare attraverso i cambiamenti etnici, religiosi e di civiltà del Medioevo la continuità delle capacità intellettuali lasciate in eredità dall'antichità, la necessaria e apparato terminologico. Senza la partecipazione della scolastica, ogni ulteriore sviluppo della filosofia e della logica europee sarebbe impossibile; anche i pensatori scolastici aspramente attaccanti della prima età moderna fino all'Illuminismo e all'idealismo classico tedesco compreso, non potevano fare a meno dell'uso diffuso del vocabolario scolastico (ancora molto evidente nell'uso linguistico intellettuale dei paesi occidentali), e questo fatto è un'importante testimonianza a favore della scolastica... Affermando il pensiero in termini generali, la scolastica nel suo insieme - nonostante alcune importanti eccezioni - ha contribuito relativamente poco allo sviluppo di un gusto per l'esperienza concreta importante per Scienze naturali, ma la sua struttura si è rivelata estremamente favorevole allo sviluppo della riflessione logica; le conquiste degli scolastici in questo campo anticipano la moderna formulazione di molte questioni, in particolare, problemi di logica matematica.
Gli umanisti del Rinascimento, i teologi della Riforma e soprattutto i filosofi dell'Illuminismo, nella lotta storicamente condizionata contro i paradigmi di civiltà del Medioevo, si adoperarono per trasformare la stessa parola "scolastica" in un soprannome abusivo, sinonimo di un vuoto gioco mentale. Tuttavia, lo sviluppo della riflessione storica e culturale non ha esitato a stabilire l'enorme dipendenza dell'intera filosofia della prima età moderna dal patrimonio scolastico, la continuità delle epoche contrastanti. Basti ricordare che il concetto proposto da Rousseau e svolto un ruolo rivoluzionario così evidente "Contratto sociale" risale all'apparato concettuale della scolastica. Paradossalmente, il culto romantico-restauratore del Medioevo, che sfidava la valutazione negativa della scolastica, per molti aspetti era più lontano dal suo spirito rispetto ai critici della scolastica nell'età dell'Illuminismo (ad esempio, J. de Maistre , 1753-1821, ardente apologeta della monarchia e del cattolicesimo, ironizza sull'astrazione dell'"uomo in generale" inerente all'umanesimo illuminista, al di fuori delle nazioni e delle razze, con un movimento che ribalta, insieme all'ideologia della Rivoluzione francese, l'intero edificio dell'antropologia cattolica tradizionale e cadendo in un “nominalismo” inammissibile).
Nel mondo chiuso delle istituzioni educative cattoliche, la scolastica ha mantenuto per alcuni secoli un'esistenza periferica, ma non sempre improduttiva. Tra le manifestazioni della scolastica tardiva della prima età moderna, è necessario segnalare l'opera del gesuita spagnolo F. Suarez (1548-1617), e anche - per il suo significato di civiltà per l'area slava orientale - la versione ortodossa della scolastica, piantata a Kiev dal metropolita Peter Mohyla (1597-1647) e da lì estese la sua influenza a Mosca.
L'interesse degli studiosi cattolici per la scolastica stimolò, dopo la rottura della tradizione durante l'Illuminismo, nell'ambito dello storicismo romantico e postromantico del XIX secolo, gli studi storico-filosofici, la pubblicazione di testi, ecc.; progetto di modernizzazione del restauro della scolastica nella forma neoscolastici , che darebbe risposte alle domande moderne, mentre si presumeva, e nel 1879 fu sostenuto dall'autorità papale (l'enciclica di Leone XIII "Aeterni Patris", orientando il pensiero cattolico all'eredità di Tommaso d'Aquino - cfr. tomismo ). Un forte incentivo per questo progetto è stato nel 20 ° secolo. la situazione di opposizione alle ideologie totalitarie - nazionalsocialismo e comunismo; tale opposizione creò la necessità di un appello all'ideale della “filosofia eterna” (philosophia perennis), nonché in una sintesi tra il principio di autorità, capace di competere con l'autoritarismo del totalitarismo, e il principio di personalità opposto al totalitarismo , nel conciliare i principi morali cristiani e umanistici. È la prima metà e la metà del XX secolo. - il tempo in cui l'eredità della scolastica poteva sembrare a pensatori autorevoli (J. Marechal, 1878-1944; J. Maritain , E. Gilson e altri) un tesoro di metodi per superare problemi puramente moderni (si confronti, ad esempio, Maritain J. Scolastica e politica, 1940). Nel cattolicesimo “postconciliare” (dopo il Concilio Vaticano II 1962-65), il neoscolasticismo non scompare come opportunità, ma i confini della sua identità, così come i segni della sua presenza nella cultura moderna, sono sempre più non più tangibili.
Letteratura:
1. Aiken G. Storia e sistema della visione del mondo medievale, trad. con lui. SPb., 1907;
2. Stöckl A. Storia della filosofia medievale, trad. con lui. M., 1912;
3. Styazhkin N.I. Formazione della logica matematica. M., 1967;
4. Popov P.S. Styazhkin N.I. Sviluppo di idee logiche dall'antichità al Rinascimento. M., 1974;
5. Sokolov V.V. Filosofia medievale. M., 1979;
6. Averintsev S.S. L'aristotelismo cristiano come forma interna della tradizione occidentale e i problemi della Russia moderna - Nel libro: È lo stesso. Retorica e origini della tradizione letteraria europea. M., 1996;
7. Gilson Ε.H. L̕esprit de la philosophie médiévale. P., 1932,2 ed. I-II. P., 1944;
8. Grabmann M. Die Geschichte der scholastischen Methode, I – II. Friburgo, 1909–11 (ripubblicato V., 1957);
9. È lo stesso. Die theologische Erkenntnis- und Einleitungslehre des hl. Tommaso d'Aquino. Friburgo i. Svizzera, 1947;
10. De Wulf. Histoire de la philosophie médiévale, I – III, 6 ed. Lovanio, 1934–47;
11. Landgraf Α.Μ. Dogmengeschicte der Frühscholastik, I – IV. Ratisbona, 1952-56;
12. È lo stesso. Einführung in die Geschichte der theologischen Literatur der Frühscholastik. Ratisbona, 1956;
13. Le Goff J. Les intellectuels au moyen âge. P., 1957;
14. Chenu MD La théologie comme science au XIII e siècle, 3 ed. P., 1957;
15. È lo stesso. Das Werk des hl. Thomas von Aquin - Die deutsche Thomas-Ausgabe, Ergänzungsband II. Hdlb. - Graz – Colonia, 1960;
16. Metz J.-B. Christliche Anthropozentrik. Über die Denkform des Thomas von Aquin. Monaco 1962;
17. Wilpert P.(Hrsg.). Die Metaphysik im Mittelalter. V., 1963;
18. Lang . Die theologische Prinzipienlehre der mittelalterlichen Scholastik. Friburgo, 1964;
19. Schillebeck E. Hochscholastik und Theologie - Offenbarung und Theologie. Magonza, 1965, pp. 178-204;
20. Breidert W. Das aristotelische Kontinuum in der Scholastik, 2. Aufl. Münster, 1980;
21. Vries J. de. Grundbegriffe der Scholastik, 2. Aufl. Darmstadt, 1983;
22. Pieper J. Scholastik, 2. Aufl. Monaco 1986;
23. Pesch O.N. Tommaso d'Aquino. Grenze und Größe mittelalterlicher Theologie. Eine Einführung. Magonza, 1988, 2. Aufl., 1989;
24. Schlosser M. Cognizione et amor. Paderborn, 1990.
S.S. Averintsev
Il contenuto dell'articolo
SCOLASTICISMO. Il termine "scolastica" è etimologicamente correlato alla parola schola (scuola) mutuata dalla lingua greca. Nei centri educativi dell'era paleocristiana, gli insegnanti delle scuole istituite dalla chiesa erano chiamati scolastici; quindi, il termine "scolastica" alla fine iniziò a denotare un intero complesso di fenomeni che caratterizzarono la vita intellettuale principalmente della Chiesa cattolica romana per diversi secoli. L'era della scolastica può essere divisa in diversi periodi.
Cinque periodi della scolastica.
Il primo di questi periodi non è ancora la scolastica in senso stretto, ma piuttosto l'era della preparazione delle strade per il suo fiorire. Inizia nel IX secolo. da Giovanni Scoto Eriugena (c. 810-878) e termina alla fine del XII secolo. le attività di teologi eminenti come Anselmo di Canterbury (1033-1109), Gilberto di Porretano (1076-1154) e altri rappresentanti della scuola di Chartres, Ugo di San Vittore (1096-1141) e altri teologi della scuola di Saint Victor Abbey, Peter Abelard (1079-1142), Bernard of Clairvaux (1091-1153), Peter of Lombard (c. 1100-1160) e molti altri. I semi da loro piantati contribuirono all'eccitazione degli interessi intellettuali in tutte le classi della società e portarono ad un forte aumento del numero degli studenti (e quindi delle scuole nelle cattedrali e nelle abbazie), e successivamente alla nascita di numerose università nel XIII secolo .
Il secondo periodo, che abbraccia il XIII secolo, è chiamato "l'età d'oro della scolastica". Questa fu l'era di pensatori eccezionali come Alberto Magno (1206-1280), Bonaventura (1221-1274) e Tommaso d'Aquino (1224-1274). Seguì un periodo di declino dell'attività intellettuale, che durò fino al Rinascimento, aprendo un nuovo, quarto periodo. Eminenti pensatori di quest'epoca furono Tommaso Caetan (1469-1534), Francesco Silvestro di Ferrara ( ( 1526), Francesco de Vitoria (toria 1546), Domingo Banes (es 1604), Luis Molina ( ( 1600) , Roberto Bellarmino (1542-1621), Francisco de Suarez (1548-1617) e altri.In seguito, l'influenza di Cartesio (1596-1650) e di altri filosofi dei tempi moderni portò a un restringimento della cerchia dei pensatori scolastici e alla perdita della loro antica autorità, ma nella seconda metà del XIX secolo. la scolastica è entrata in un periodo di nuova fioritura, che continua ancora oggi. Quest'ultimo periodo è comunemente chiamato neoscolastica. L'impulso iniziale per lo sviluppo della neoscolastica è stato dato dall'enciclica Aeterni patris(1879) di papa Leone XIII, che conteneva un appello a tornare ai veri insegnamenti della scolastica medievale (in primis a quelli di Tommaso d'Aquino), nonché alcune encicliche successive.
La diversità interiore della scolastica.
Che cos'è la scolastica? È tanto più difficile rispondere a questa domanda perché il termine stesso è stato applicato a una cerchia molto ampia di pensatori, non solo separati l'uno dall'altro per secoli, ma anche diversi nelle loro opinioni. Sebbene tutti concordassero tra loro sui temi della dottrina chiaramente espressi nella divina Rivelazione e ufficialmente approvati dalla Chiesa Cattolica Romana, tuttavia, nell'ambito di tale dottrina, ciascuno scolastico ha sviluppato e interpretato queste verità alla luce della propria opinioni filosofiche e attingendo alle tue idee. In tutto ciò che è rimasto al di là della dottrina accettata dalla chiesa, si possono trovare le differenze più profonde e spesso inconciliabili di atteggiamenti e posizioni. Così, per esempio, nel XIII secolo. Molte delle idee avanzate da Tommaso d'Aquino erano radicalmente diverse da quelle sostenute dal maestro di Tommaso, Alberto Magno, o da un altro eminente teologo della stessa epoca, Bonaventura. Nel secolo successivo, i teologi che si definivano tomisti ingaggiarono accese dispute con i seguaci di Duns Scoto (c. 1275-1308) e con i seguaci di William Ockham (c. 1285-1349), che, a loro volta, erano spesso in disaccordo con l'un l'altro. ... Nel 20 ° secolo. troviamo un'altrettanto ampia varietà di vedute. Oltre agli scotisti, agli occamisti e ai suaristi, ci sono anche i tomisti che si definiscono essenzialisti, e i tomisti che si definiscono autentici esistenzialisti (distinguendosi dagli esistenzialisti "radicali", J.P. Sartre e altri filosofi). Pertanto, la scolastica dovrebbe essere intesa non tanto come una comunità di insegnamenti, ma come un unico ambiente spirituale in cui i vari scolastici hanno sviluppato i loro insegnamenti.
L'età d'oro della Scolastica.
Cos'è stato questo mercoledì? Forse la risposta a questa domanda sarà più facile se ci rivolgiamo all'"età dell'oro" della scolastica. In questa epoca, l'atmosfera spirituale era caratterizzata, in primo luogo, dalla priorità incondizionata della fede sulla ragione e, in secondo luogo, dall'esistenza di metodi specifici e accuratamente sviluppati di insegnamento agli "scolari".
La priorità della fede.
Per capire da dove provenisse l'idea della superiorità della fede sulla ragione, basta ricordare che le università medievali, per loro origine, sono direttamente collegate alle scuole cattedrali e monastiche. È più difficile immaginare cosa abbia significato in pratica il riconoscimento di questa priorità e quali conseguenze abbia portato. Innanzitutto la medicina e il diritto (sia canonico che civile), essendo discipline universitarie, erano completamente subordinate al controllo ecclesiastico. Ancora più importante, anche la facoltà di "scienze liberali" (cioè filosofia) era sotto controllo. Talvolta questo controllo si esprimeva nella condanna da parte dei vescovi locali, che seguivano i consigli (talvolta rasentando l'istigazione) di rappresentanti delle facoltà teologiche, quelle conclusioni filosofiche che contraddicevano le verità della fede. Ne è un esempio la condanna nel 1270 di tredici tesi filosofiche, tra cui la seguente: “Che la volontà umana si esprime e fa scelte per necessità... Che il mondo è eterno... Che l'anima è danneggiata quando il corpo è danneggiato... Che Dio non possieda cognizione di cose private e speciali... Che le azioni umane non siano dirette dalla divina Provvidenza».
Di particolare importanza era il modo in cui gli stessi teologi usavano la filosofia. La loro attenzione era sulle verità comunicate nella Rivelazione divina, che non solo dovevano essere protette dalle interpretazioni eretiche, ma anche chiarite, sviluppate e interpretate in modo appropriato. Per svolgere questi compiti, i teologi di solito dovevano fare affidamento sulle idee di pensatori di epoche precedenti, inclusi i filosofi. Di conseguenza, non solo sono giunti a una comprensione più profonda delle singole posizioni teologiche, ma hanno anche sviluppato i propri concetti filosofici. Ad esempio, poiché i teologi in connessione con la dottrina trinitaria e cristologica hanno sviluppato i concetti di "Persona" e "natura", nei loro scritti si può trovare una penetrazione più profonda nella filosofia della "personalità" e della "natura" che negli scritti di filosofi non esperti nel risolvere problemi teologici. ... Allo stesso modo, poiché erano occupati a chiarire il significato del concetto di "essere" in relazione a Dio e alle sue creazioni, nei loro trattati troviamo varie varianti della metafisica dell'essere, utilizzando le realizzazioni della precedente tradizione filosofica, ma a allo stesso tempo superando di gran lunga quanto fatto dai filosofi precedenti ... Erano i teologi del XIII secolo. diede un contributo significativo e molto tangibile allo sviluppo della metafisica, della psicologia, della teoria della conoscenza e di altre discipline filosofiche.
L'atteggiamento prevalente nei confronti della teologia nella scolastica ha portato a conseguenze molto importanti, espresse in una sorta di "dualità di approcci" che caratterizza l'atmosfera stessa della vita intellettuale nell'"età dell'oro" della scolastica. I teologi vedevano il loro compito nel proteggere, sviluppare e interpretare le verità affermate dalla fede. Uno dei mezzi per garantire l'attuazione di questo compito era uno studio approfondito delle opere dei loro predecessori. Naturalmente, queste erano principalmente le opere di autori cristiani - Gregorio di Nissa, Giovanni di Damasco e altri padri della chiesa greci e latini: Agostino, Ilario di Pictavia, Boezio, Beda il Venerabile, Isidoro di Siviglia e altri. Tuttavia, leggevano avidamente e (ove possibile) usavano tutte le opere di Platone, Aristotele, Proclo e altri filosofi a loro disposizione, così come le opere arabe (al-Farabi, al-Ghazali, Avicenna, Averroè) ed ebraiche ( ibn-Gebirol, Moses Maimonide) di autori medievali.
Metodologia "scuola".
Oltre a riconoscere la superiorità della fede sulla ragione, l'atmosfera del pensiero scolastico si caratterizzava anche per l'uso di metodi specifici subordinati ai compiti dell'insegnamento "scolastico". Il principale e più degno di nota di questi metodi era il metodo di discussione (cioè il metodo delle "domande" e delle "risposte", che assumeva la considerazione di ciascun argomento nella forma: "Una domanda sorge qui ..."), che era quasi obbligatorio usato da tutti gli scolastici.
Tale approccio era finalizzato principalmente a giungere ad una conclusione definitiva sull'argomento o problema in esame solo dopo che tutte le possibili risposte al quesito posto sono state soppesate e valutate. Tuttavia, lo scopo di questo metodo non era solo quello di arrivare alla conclusione corretta, ma anche di addestrare gli scienziati a pensare, valutare affermazioni e giungere a conclusioni ragionevoli e valide. Questo metodo è stato ugualmente efficace quando insegnamenti fondamentali e generalmente accettati sono stati sottoposti a tale discutibile considerazione, e quando è stato utilizzato per studiare posizioni nuove e controverse. Fu lui a determinare l'originalità di genere della maggior parte delle opere scolastiche emerse dalle mura delle università medievali. Per esempio, Quaestiones disputatae Le (questioni controverse) non erano altro che un resoconto di controversie effettive, tenuto settimanalmente o bisettimanalmente, e rivelando la più ampia gamma di opinioni e punti di vista diversi. Per genere quaestiones disputatae appartiene, in particolare, la composizione di Tommaso d'Aquino Sulla verità, che si riferisce al periodo del suo insegnamento all'Università di Parigi (1256-1259) e contiene 253 domande separate riguardanti il problema della verità e il problema del bene. Le "somme" medievali erano una presentazione olistica e sistematica della filosofia o della teologia nella loro interezza (da cui il termine "somma" stesso), basata sullo stesso metodo di considerazione globale dei problemi. Questo metodo è stato utilizzato anche nei commenti a Pietro di Lombardo, Aristotele, Boezio e Un libro sulle ragioni quando era necessario andare oltre il significato letterale già esaurito.
Un'altra caratteristica della metodologia della "scuola" medievale era lo sforzo costante di insegnanti e studenti di pensare ed esprimere i propri pensieri nella forma più chiara, precisa e rigorosa.
Scolastica nelle epoche successive.
L'atmosfera intellettuale dei secoli successivi era caratterizzata dalle stesse due caratteristiche principali, ma aveva anche i suoi tratti caratteristici. Nel 14 ° secolo. alla nozione di superiorità della fede sulla ragione si aggiunse una notevole sfiducia nei confronti della ragione e della speculazione filosofica (che si spiega con la condanna a Parigi nel 1277 dell'interpretazione averroista di Aristotele), che in seguito portò a una rottura tra teologia e filosofia. Molti scolastici iniziarono ad utilizzare il metodo problematico non tanto per risolvere problemi fondamentali quanto per proteggere gli insegnamenti di Tommaso d'Aquino dalle critiche di Duns Scoto, o, al contrario, per proteggere Duns Scoto dalle critiche dei tomisti e di Occam. Tuttavia, durante il Rinascimento, molti pensatori della chiesa giunsero alla convinzione che riconoscere la superiorità della fede non implicasse affatto scetticismo nei confronti della filosofia. Inoltre, si sono rivolti alla soluzione di problemi relativi al campo delle teorie politiche, ad esempio, al problema dei rapporti tra chiesa e stato, papa e governanti secolari, alla questione dell'origine e dell'essenza della società civile e alla la questione della possibilità dell'unità delle nazioni. Risolvendo questi problemi, gli scolastici hanno dato un contributo significativo allo sviluppo della democrazia occidentale. Hanno anche cercato di capire il rapporto tra la libertà della volontà umana e la predestinazione divina, tuttavia, nonostante gli sforzi profusi e molti scritti su questo argomento, non sono riusciti a ottenere un successo significativo in questo campo. Nonostante il sano e fruttuoso approccio dei pensatori di quest'epoca alla discussione dei problemi di principio, molto sforzo ed energia furono ancora spesi nelle faide tra gesuiti, francescani e domenicani. Per finire, il metodo problematico alla fine è degenerato in un metodo di "tesi". Quest'ultimo consisteva nel fatto che l'insegnante avanzava una certa posizione o tesi che avrebbe difeso. Quindi ha chiarito il suo punto di vista, fornendo elementi atti a confermare la correttezza della sua posizione, e ha quindi risposto alle obiezioni proposte. Da un punto di vista pedagogico, questo metodo è stato molto meno fruttuoso del metodo del problema, poiché non implicava una valutazione preliminare e una considerazione di tutte le possibili risposte alla domanda posta. Inoltre, nel XVI e XVII secolo. sviluppò la scolastica della persuasione calvinista, che era una filosofia che riconosceva la superiorità della fede (pur non riconoscendo l'autorità dogmatica della Chiesa romana) e basata sul metodo della "tesi".
In che modo queste due caratteristiche principali che caratterizzano la scolastica si riflettevano nella neoscolastica? Con alcune riserve, si può riconoscere che la scolastica moderna ha fatto rivivere molte delle caratteristiche più notevoli della scolastica medievale. Grazie a uno studio imparziale delle opere originali di teologi e filosofi delle epoche precedenti, molti scolastici moderni sono tornati alla convinzione che la dottrina della superiorità della fede sulla ragione non abolisce affatto la filosofia cristiana, ma la arricchisce e la sviluppa.